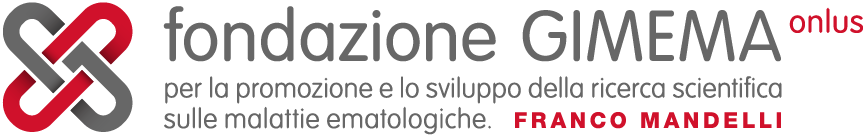Una nuova ricerca ha portato alla creazione di un modello, immediatamente applicabile, in grado di supportare la diagnosi differenziale tra la trombocitemia essenziale e la più rischiosa mielofibrosi primaria prefibrotica. Basandosi sui livelli dei globuli bianchi e delle piastrine questo modello è utile da subito per indirizzare i medici verso una biopsia ossea tempestiva
Le neoplasie mieloproliferative (MPNs, dall’acronimo inglese myeloproliferative neoplasms) Philadelphia negative sono un gruppo di patologie ematologiche croniche caratterizzate da una produzione cellulare anomala nel midollo osseo. Fanno parte di questo gruppo la trombocitemia essenziale (ET, essential thrombocythemia), la policitemia vera (PV) e la mielofibrosi primaria (PMF, primary myelofibrosis). All’interno di questo gruppo la distinzione tra la trombocitemia essenziale e la mielofibrosi primaria prefibrotica (pre-PMF), rappresenta una sfida diagnostica fondamentale per la corretta stratificazione del rischio legato a ciascuna di queste due patologie, e l’appropriata pianificazione di monitoraggio e di terapia.
Un recente studio internazionale, guidato dal Professor Tiziano Barbui, direttore scientifico di FROM – Fondazione per la Ricerca dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e Primario Emerito della Ematologia dell’Ospedale di Bergamo, pubblicato recentemente sull’American Journal of Hematology, propone un modello basato su parametri ematologici di routine per supportare i clinici in questa distinzione.
La pre-PMF è una importante entità clinico-patologica, ma complessa da identificare
Nella revisione della classificazione World Health Organization (WHO) del 2008, la pre-PMF è stata riconosciuta come entità clinico-patologica a sé stante tra le neoplasie mieloproliferative, grazie all’enfasi posta sull’analisi istologica integrata con i dati molecolari.
Ma distinguere la pre-PMF dalla ET non è immediato: entrambe si manifestano tipicamente con trombocitemia (elevato numero di piastrine) e spesso presentano una frequenza simile della mutazione JAK2(V617F), che è il marcatore più frequente nelle neoplasie mieloproliferative.
Dal punto di vista diagnostico l’essenza della pre-PMF risiede nelle alterazioni dei megacariociti, cioè le cellule presenti nel midollo osseo che producono le piastrine, le cui anomalie morfologiche (come l’atipia o l’aggregazione), assieme alla presenza di fibrosi, sono considerate i pilastri della diagnosi differenziale. Per accertare queste caratteristiche è quindi necessaria la biopsia del midollo osseo.
Spiega Barbui: “Conoscere la pre-PMF è importante perché richiede un monitoraggio accurato per riconoscere precocemente una possibile evoluzione in mielofibrosi conclamata, che si associa a sintomi talvolta gravi, complicanze legate alla possibile anemia e piastrinopenia e alla ridotta sopravvivenza di questi pazienti. In questi casi un pronto intervento con farmaci può alleviare le complicazioni, anche se la guarigione può essere raggiunta solo con il trapianto di midollo osseo”.
Questa storia clinica della pre-PMF è stata descritta in uno studio internazionale del 2011, co-diretto da Barbui. Lo studio aveva incluso 1.104 pazienti, che avevano ricevuto una diagnosi di trombocitemia essenziale eseguita tra il 1975 e il 2008. Nel 2010 tutti questi casi sono stati riesaminati, e le biopsie ossee sottoposte a una rigorosa revisione secondo i criteri aggiornati. Questo riesame è stato eseguito dal Dottor Juergen Thiele, ematopatologo, co-investigatore del progetto e co-autore dei capitoli WHO sui criteri diagnostici delle MPNs, che aveva contribuito a definire la pre-PMF nell’ambito della WHO. La revisione ha portato alla riclassificazione di 180 pazienti (16%) come pre-PMF, mentre 891 casi sono stati confermati come ET (33 campioni sono stati scartati in quanto inadeguati). Non solo: il confronto dei risultati clinici ha dimostrato anche che la pre-PMF era associata a una prognosi peggiore: il rischio a 10 anni di trasformazione leucemica era significativamente più alto nella pre-PMF (5,8%, rispetto allo 0,7% della ET) e anche il rischio di progressione verso la mielofibrosi conclamata a 10 anni era maggiore nella pre-PMF (12,3% rispetto alla ET, con lo 0,8%).
I limiti della diagnosi e l’aiuto offerto dal nuovo modello
Nonostante l’analisi istologica del midollo osseo sia il metodo diagnostico di riferimento, può essere comunque complesso distinguere tra trombocitemia essenziale e mielofibrosi primaria prefibrotica, soprattutto nei casi precoci o borderline. Questo accade sia perché la morfologia midollare può non dimostrare chiare differenze tra le due malattie, sia perché patologi diversi non sempre concordano sull’interpretazione di quanto osservato al microscopio. Sebbene la morfologia da sola permetta di classificare correttamente il 72% dei casi (quando almeno tre revisori su quattro concordano con la diagnosi di consenso), l’integrazione con dati clinici e molecolari è indispensabile per una classificazione.
Questo è il contesto in cui si inserisce il lavoro più recente di Barbui e colleghi, che include esperti anatomopatologi sia nazionali che internazionali, oltre che autori dei criteri diagnostici delle neoplasie mieloproliferative afferenti alla WHO. L’obiettivo è stato valutare, attraverso il confronto tra questi esperti, se i parametri ematologici di routine – in questo caso la conta dei globuli bianchi (WBC, white blood count) e delle piastrine (PLT, platelets) – potessero aiutare a distinguere la ET dalla pre-PMF, o meglio stimare la diversa probabilità di trovarsi di fronte all’una o all’altra malattia.
Lo studio, pubblicato a ottobre, ha utilizzato nuovamente i dati dei 1071 pazienti che, grazie al riesame del 2010, ora avevano una diagnosi precisa.
L’analisi ha valutato l’interazione tra i livelli di globuli bianchi e piastrine, e ha sviluppato un modello che associa l’elevato conteggio di entrambi i parametri (oltre una soglia) alla probabilità di una diagnosi di mielofibrosi primaria prefibrotica.
In particolare, lo studio ha definito tre profili di rischio. I pazienti con livelli inferiori sia di globuli bianchi che di piastrine costituiscono il gruppo a probabilità più bassa di mielofibrosi prefibrotica (pari a circa il 6%). Tuttavia, quando uno o l’altro dei parametri supera la soglia, la probabilità di pre-PMF aumenta, collocandosi in una fascia di rischio intermedio di circa il 18%–19%. L’associazione di rischio più significativa emerge però quando i pazienti presentano livelli elevati sia di WBC che di PLT: in questo caso, la probabilità di pre-PMF raggiunge il 26%, oltre quattro volte superiore rispetto al gruppo a basso rischio.
L’idea di usare gli esami del sangue a supporto della diagnosi era già stata avanzata dagli studiosi del gruppo di Tiziano Barbui in via esplorativa nel 2012, con una lettera sulla stessa rivista. In quell’occasione, era stato sviluppato un algoritmo diagnostico sui livelli di emoglobina, globuli bianchi e LDH (lattico deidrogenasi), ma in quel caso ognuno dei parametri era preso in considerazione indipendentemente dagli altri. Nello studio attuale, invece, il modello è multivariato, cioè considera l’interazione tra i singoli parametri. In questo modo è stata identificata un’interazione statisticamente significativa tra WBC e PLT, il che indica che il loro effetto sinergico sul rischio di malattia non appare semplicemente additivo.
L’associazione tra l’aumento combinato di globuli bianchi e piastrine e la diagnosi di pre-PMF rimane robusta e significativa anche dopo l’aggiustamento statistico per altri marcatori, come l’LDH sierico e la splenomegalia.
I ricercatori quindi concludono che è possibile utilizzare questi parametri ematologici di routine per supportare la diagnosi e guidare l’uso appropriato della biopsia midollare, specialmente nei casi ambigui.
Spiega Barbui: “Questo modello non sostituisce la diagnosi definitiva di mielofibrosi attraverso la biopsia ossea, che resta il “gold standard”. Ma quando l’analisi istologica è ambigua o borderline, come avviene spesso nei casi precoci, il riscontro di questi valori ematici elevati è un’indicazione che può aiutare il patologo a riconsiderare la diagnosi. Di conseguenza, sapere che un paziente presenta valori ematici associati a un rischio elevato di pre-PMF richiede l’adozione di iniziative di monitoraggio e di terapia che possono essere diverse rispetto a quelle riservate alla trombocitemia essenziale”.
Implicazioni cliniche immediate
Il modello WBC-PLT offre quindi uno strumento pratico e immediatamente interpretabile. Non è destinato a sostituire l’esame morfologico, ma a supportare il giudizio clinico.
Il modello, spiega il professore, può anche aiutare a stabilire se la valutazione istopatologica (biopsia) deve essere intrapresa più urgentemente. Per esempio, nei pazienti con trombocitosi isolata, la probabilità di pre-PMF è bassa (6%), e la biopsia ossea in questo caso può essere dilazionata. Al contrario, la presenza di anomalie ematologiche combinate (WBC e PLT elevati) suggerisce un rischio notevolmente più alto e, “giustifica una tempestiva valutazione istopatologica, in modo da arrivare al più presto a una diagnosi”.
Il modello, come ricordato, è stato sviluppato su dati raccolti in modo retrospettivo, e come sempre gli autori sottolineano la necessità di una validazione prospettica. Tuttavia, spiega Barbui, a causa della difficoltà nel condurre studi che durino 10 o 15 anni, e data l’accessibilità dei parametri utilizzati, il modello può essere usato da subito per supportare le decisioni diagnostiche e cliniche.
Proprio per la sua utilità clinica immediata, Barbui specifica che l’American Journal of Hematology ha pubblicato immediatamente il manoscritto sottomesso. Gli editors della rivista hanno ritenuto di dover mettere queste conoscenze rapidamente a disposizione degli ematologi, che potrebbero non essere esperti nella complessa distinzione tra ET e pre-PMF.
Una diagnosi precoce è fondamentale per organizzare un follow-up adeguato. Questo studio, concludono gli autori, contribuisce a definire una strategia diagnostica raffinata e adattata al rischio nella gestione delle MPNs.
L’articolo originale di Barbui T. et al., A Clinically Applicable Model Using Blood Counts to Support the Diagnosis of Prefibrotic Myelofibrosis Versus Essential Thrombocythemia, pubblicato su American Journal of Hematology è disponibile al seguente link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.70017