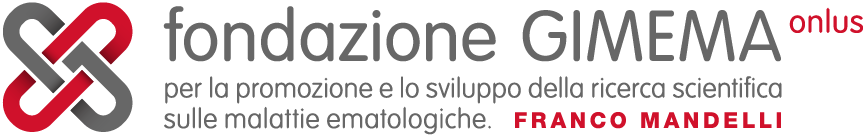L’insufficienza midollare è la più temuta conseguenza dell’anemia di Fanconi, e può essere corretta dal trapianto. L’intervento, tuttavia, è rischioso, e nel tempo favorisce l’insorgenza di tumori. Lo studio retrospettivo su 193 pazienti, trapiantati e non, dimostra che la progressione verso l’insufficienza midollare non è la stessa per tutti i pazienti, suggerendo la possibilità di individuare per ognuno il momento ottimale per intervenire col trapianto.
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche ha cambiato la storia dell’anemia di Fanconi, ma non è una cura definitiva e comporta rischi significativi a lungo termine, come l’insorgenza di tumori. Scegliere se e quando intervenire è una delle decisioni più complesse per i clinici. Un nuovo studio pubblicato sull’American Journal of Hematology, basato sui dati del Registro Italiano Anemia di Fanconi (RIAF) e coordinato dal dottor Carlo Dufour, può offrire uno strumento in più per orientare queste scelte.
Che cos’è l’anemia di Fanconi
L’anemia di Fanconi (AF) è una patologia complessa e multiforme. Come spiega il Dott. Dufour, “è una malattia rara, genetica, sistemica, che determina una costellazione di sintomi, tutti molto gravi, che includono sia manifestazioni del sangue sia manifestazioni extraematologiche”.
La sua base biologica risiede in un difetto nei meccanismi di riparazione del DNA: le cellule dei pazienti non riescono a riparare correttamente i danni al proprio patrimonio genetico, portando a un’aumentata fragilità cromosomica che è alla base sia del test diagnostico principale sia di molte manifestazioni cliniche. Oltre al deficit nella riparazione del DNA, le cellule dei pazienti mostrano un’ipersensibilità a citochine infiammatorie, radicali liberi e aldeidi, fattori che contribuiscono ulteriormente a danneggiare il DNA.
Il risultato è una malattia complessa che include un ampio spettro di malformazioni congenite e due fenomeni che insorgono progressivamente: l’insufficienza midollare (BMF, Bone Marrow Failure), e un’elevata predisposizione a sviluppare diversi tipi di tumori, in particolare carcinomi a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC, Head and Neck Squamous Cell Carcinoma) e neoplasie ematologiche.
Il trapianto e le sue complicanze
Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche ha cambiato la storia dell’anemia di Fanconi, correggendo l’insufficienza midollare e prolungando la sopravvivenza. Il trapianto è allogenico, idealmente da donatore familiare HLA-identico o da donatore compatibile da registro internazionale. Tuttavia, non è una cura definitiva: non corregge il difetto genetico e aumenta ulteriormente il rischio di tumori.
Una delle complicanze del trapianto è infatti la malattia del trapianto contro l’ospite (GvHD, Graft versus Host Disease), dove le cellule del donatore attaccano i tessuti dell’ospite. Questa reazione immunitaria genera uno stato infiammatorio che contribuisce ulteriormente a danneggiare il DNA e quindi all’oncogenesi.
Come sottolinea Dufour, “Per un paziente con l’anemia di Fanconi, fare il trapianto e avere la GvHD significa aumentare di molto il rischio di avere un tumore 10-15 anni dopo.”
La gestione della malattia impone quindi al clinico un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici del trattamento, e i nuovi dati emersi dallo studio di Dufour e colleghi possono offrire un aiuto per tali decisioni cliniche. In particolare, per individuare il momento ottimale per l’intervento.
I risultati dello studio sul Registro Italiano Anemia di Fanconi
Lo studio è retrospettivo e basato sul Registro Italiano Anemia di Fanconi, uno dei più ampi e curati al mondo. È stato fondato nel 1994 dalla dottoressa Adriana Zatterale presso il Servizio di Genetica dell’Ospedale Elena d’Aosta dell’ASL Napoli 1 Centro, e negli ultimi anni è stato unificato con un altro registro, in parte sovrapposto, gestito dal Gaslini.
L’analisi è stata condotta su 193 pazienti diagnosticati tra il 1982 e il 2021, di cui 130 (67,4%) sottoposti a trapianto e 63 (32,6%) non trapiantati, seguiti per un periodo mediano di 6,9 anni. I dati confermano innanzitutto i progressi della medicina: la sopravvivenza globale a 30 anni è del 47,4%, con un’età mediana di sopravvivenza di 29,1 anni, un netto miglioramento rispetto ai dati storici.
Nell’intera coorte, le infezioni sono state la prima causa di morte, seguite dai tumori. Analizzando specificamente il gruppo dei trapiantati, invece, la mortalità legata alla procedura, che include GvHD, infezioni o insufficienza d’organo, è stata la causa principale, responsabile del 71,4% dei decessi in questo sottogruppo. Tuttavia, è importante sottolineare che la mortalità legata alla procedura è diminuita nel tempo: la frequenza dei decessi nei trapianti eseguiti prima del 2000 era del 66,7%, mentre è scesa al 27,8% in quelli successivi, grazie all’introduzione di nuovi farmaci come la fludarabina, un chemioterapico che facilita l’attecchimento del trapianto. Il rischio di sviluppare neoplasie (ematologiche o solide) è quasi tre volte maggiore nei pazienti sottoposti a trapianto rispetto a quelli non trapiantati. Il carcinoma a cellule squamose della testa e del collo è stato il tumore più frequente in entrambi i gruppi.
Il principale valore scientifico del lavoro, come nota Dufour, risiede nell’aver analizzato anche il gruppo dei non trapiantati, solitamente poco studiato. Ma come confrontare in modo equo pazienti che ricevono un trattamento in momenti diversi della loro malattia con quelli che non lo ricevono affatto?
I ricercatori hanno fatto partire il “cronometro” dell’analisi per tutti i pazienti, trapiantati e non, dallo stesso momento, ovvero quando raggiungevano i criteri clinici per essere candidati al trapianto (per esempio, lo sviluppo di una citopenia di grado moderato), che non coincide necessariamente col momento in cui il trapianto è effettuato.
In questo modo è emerso che, nel sottogruppo con citopenia moderata, la mortalità nei non trapiantati ha iniziato a manifestarsi solo dopo 10 anni dall’eleggibilità.
Come spiega Dufour, questo significa che la progressione verso l’insufficienza midollare non è automatica: “Non tutti pazienti sono uguali, alcuni mostrano un rapido peggioramento, ma altri rimangono stabili, anche per un lungo periodo”.
In due casi del campione, questa stabilità sembra dovuta al mosaicismo somatico ematopoietico, una condizione in cui nel paziente si sviluppa una popolazione di cellule del sangue priva delle mutazioni dell’Anemia di Fanconi, che riesce a contrastare gli effetti delle cellule malate: una sorta di “terapia genica spontanea”.
Il momento giusto per il trapianto
Un tempo la principale causa di morte per i pazienti era l’insufficienza midollare. Oggi, grazie al trapianto, i malati vivono più a lungo, ma l’intervento non è esente da rischi, e aumenta molto la probabilità di sviluppare tumori in futuro.
Lo studio, però, dimostra che non tutti i pazienti che hanno raggiunto i criteri per il trapianto sono immediatamente a rischio di sviluppare l’insufficienza midollare, e che quindi è possibile mantenere un’attesa vigile e ritardare l’intervento fino a quando diventa necessario.
Spiega Dufour: “Bisogna seguire attentamente il paziente e intercettare il momento giusto. Se lo si trapianta troppo presto, quando non ci sono ancora sintomi gravi, si rischia di infliggere un rischio di mortalità del 10-15% a un paziente che avrebbe potuto vivere ancora a lungo senza la procedura. E, in caso di successo, accelerare l’insorgenza dei tumori”. Questo momento, secondo i dati, coincide con la fase in cui “una citopenia moderata sta scivolando verso una severa. È quello, probabilmente, il momento in cui il rapporto costo-beneficio pende a vantaggio del fare il trapianto”.
Lo studio, quindi, non intende sminuire il valore del trapianto, che resta l’unica opzione in grado di correggere stabilmente l’insufficienza midollare. Piuttosto, fornisce ai clinici uno strumento su dati reali per prendere decisioni cliniche più robuste e personalizzate.
Questi risultati rafforzano la necessità di un monitoraggio attento e continuo, volto a massimizzare i benefici della procedura e a limitare i rischi per pazienti che potrebbero vivere più a lungo senza un intervento ad alta complessità. In attesa di future opzioni terapeutiche come la terapia genica, che la comunità scientifica attende con grande interesse, ottimizzare la gestione clinica attuale, come dimostrato da questo studio, rappresenta il passo più concreto per migliorare la durata e la qualità di vita dei pazienti con Anemia di Fanconi.
L’articolo originale di Ricci E., et al. Long-Term Outcome of Fanconi Anemia Patients From the Italian Registry on Behalf of the Marrow Failure Study Group of the AIEOP (Italian Association for Pediatric Haematology-Oncology), pubblicato su American Journal of Hematology è disponibile al seguente link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajh.27724
Imagine in copertina generata con AI