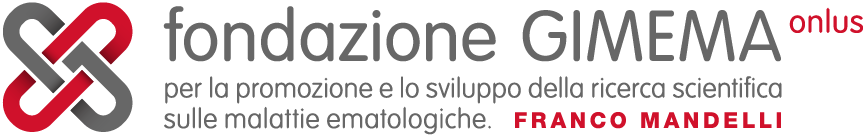Le terapie per il linfoma non Hodgkin a cellule B refrattario sono cambiate molto negli ultimi anni, con l’avvento di trattamenti con cellule CAR-T. Qual è allora oggi il ruolo del trapianto allogenico di cellule staminali? I risultati di uno studio multicentrico italiano cercano di fare luce su benefici e rischi di questi trattamenti.
Per molto tempo il trattamento per il linfoma non Hodgkin a cellule B (B-NHL) refrattario si è basato sul trapianto allogenico di cellule staminali (allo-HSCT), che consiste nella sostituzione del midollo osseo malato con cellule staminali sane provenienti da un donatore compatibile. A differenza del trapianto autologo (che utilizza le cellule del paziente stesso), il trapianto allogenico offre un vantaggio unico: il sistema immunitario del donatore è in grado di riconoscere e attaccare eventuali cellule tumorali residue, un fenomeno chiamato effetto graft-versus-lymphoma. Tuttavia, la procedura è molto complessa e comporta rischi gravi, tra cui infezioni potenzialmente letali e la cosiddetta malattia del trapianto contro l’ospite (GVHD), in cui le cellule immunitarie del donatore attaccano i tessuti sani del paziente.
Negli ultimi due decenni, tuttavia, i trattamenti per questo tipo di linfomi sono cambiati radicalmente: uno dei progressi più significativi è stata l’introduzione della terapia con cellule CAR-T, un trattamento innovativo che utilizza le cellule immunitarie del paziente stesso, modificate in laboratorio, per individuare e distruggere le cellule tumorali.
Poiché la CAR-T e altre nuove immunoterapie sono potenti e generalmente meglio tollerate rispetto ai trapianti tradizionali, sono diventate le opzioni preferite per i pazienti il cui linfoma recidiva o è resistente al trattamento standard.
Qual è allora il ruolo del trapianto dell’allo-HSCT ora, alla luce di queste nuove opzioni terapeutiche? Per rispondere a tale domanda, un recente studio multicentrico italiano ha esaminato 285 procedure di trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche eseguite tra il 2000 e il 2020 in pazienti con linfomi a cellule B recidivanti o refrattari, che avevano già ricevuto trattamenti multipli, purtroppo inefficaci.
I ricercatori hanno seguito i pazienti per una media di quasi nove anni. Questo ha permesso di valutare la sopravvivenza a lungo termine, che è risultata del 50.4% a 3 anni e del 46.6% a 9 anni, con una sopravvivenza libera da progressione di malattia del 39.3% a 9 anni. Purtroppo, la procedura è stata gravata da importanti tossicità correlate al trattamento, e circa un paziente su tre è deceduto per complicanze precoci o tardive derivanti dal trapianto, il più delle volte infezioni o GVHD. Nello stesso tempo va sottolineato che oltre il 30% di pazienti sono risultati lungo sopravviventi, senza segni di malattia e quindi potenzialmente guariti, a conferma dell’efficacia terapeutica del trapianto allogenico.
Analizzando più nel dettaglio i risultati, emergono differenze sostanziali nelle sottopopolazioni di pazienti: “I pazienti con linfoma indolente, in massima parte di tipo follicolare, hanno ottenuto i risultati migliori, mentre i risultati meno soddisfacenti si sono osservati nel sottogruppo, per altro meno numeroso, di pazienti con linfoma a cellule mantellari – spiega Corrado Tarella, responsabile del Programma Ematologia e del Cell Therapy Project all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, e primo autore dello studio–. Questo è probabilmente dovuto a una biologia più aggressiva del linfoma mantellare recidivato/refrattario. In ogni caso, la remissione prima del trapianto è il fattore complessivamente più rilevante: i pazienti che sono stati sottoposti a trapianto in remissione completa hanno infatti avuto una sopravvivenza migliore, senza significative differenze tra i sottotipi istologici”.
La terapia CAR-T è diventata la prima scelta per molti pazienti con linfoma a cellule B recidivanti o refrattari: è molto efficace, meno tossica rispetto alle procedure trapiantologiche e può essere offerta a pazienti anziani o più fragili.
Anche gli anticorpi bi-specifici rappresentano ora una nuova, importante, opzione terapeutica. Tuttavia, non tutti i pazienti rispondono in modo duraturo a queste terapie, e alcuni pazienti possono avere una ripresa di malattia, a breve o medio termine, dopo CAR-T e/o anticorpi bi-specifici. L’allo-HSCT potrebbe ancora offrire delle possibilità di cura e anche di guarigione per questi pazienti, qualora le varie opzioni terapeutiche, ora disponibili, abbiano fallito.
L’articolo originale di Tarella E, et al. Long-Term Outcomes After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Relapsed/Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma: An Italian Multicenter Collaborative Study, pubblicato su Transplantation and Cellular Therapy è disponibile al seguente link: https://doi.org/10.1016/j.jtct.2025.06.004