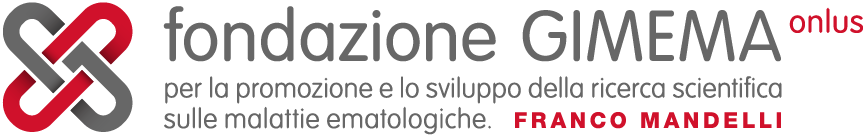Una revisione critica pubblicata sull’American Journal of Hematology ripercorre quarant’anni di ricerca sul recettore CD30. Harald Stein e Brunangelo Falini, tra i protagonisti di questi studi, illustrano come l’identificazione di questo marcatore abbia consentito di definire nuove entità clinico-patologiche e di sviluppare efficaci terapie di precisione.
Comprendere la biologia dei tumori del sangue e sviluppare terapie efficaci può richiedere decenni di ricerca, ma i risultati possono essere straordinari. La storia del CD30 ne è un esempio. Si tratta di una molecola appartenente alla superfamiglia dei recettori del fattore di necrosi tumorale (TNF), che ha avuto un ruolo centrale nella comprensione, nella diagnosi e nel trattamento di diversi tipi di linfomi. La sua identificazione, avvenuta negli anni Ottanta, ha permesso di chiarire l’origine delle cellule del linfoma di Hodgkin, e ha reso possibile distinguere con maggiore precisione questa malattia dal linfoma anaplastico a grandi cellule (ALCL) e da altre forme linfoproliferative che in passato venivano confuse con metastasi di tumori solidi. Infine, la specificità di questo recettore ha permesso lo sviluppo di terapie mirate che hanno migliorato la prognosi dei linfomi dove esso è espresso. Nel linfoma di Hodgkin avanzato (stadi III o IV), in particolare, la sopravvivenza libera da progressione arriva a sfiorare il 95% grazie ai nuovi standard di cura che includono l’immunoterapia.
Questo lungo cammino scientifico è stato ripercorso di recente da Harald Stein e Brunangelo Falini, due dei suoi principali protagonisti, in un articolo pubblicato sull’American Journal of Hematology. Stein è stato il patologo di riferimento presso il Centro tedesco di ematopatologia di Berlino, mentre Falini è professore ordinario di ematologia presso l‘Università di Perugia.
“Con questa review abbiamo voluto mostrare come la scoperta della molecola CD30, molti anni fa, abbia aperto la strada alle terapie mirate oggi disponibili”, spiega Falini.
L’identificazione di CD30
Il linfoma di Hodgkin è rimasto un enigma biologico per diversi anni perché le sue cellule maligne (cellule di Reed-Sternberg) erano troppo rare per essere isolate e studiate, rappresentando appena lo 0,5%-2% della massa tumorale. La svolta arrivò solo nel 1979 con la linea cellulare di Hodgkin L428, che fornì finalmente un modello autentico della malattia da studiare stabilmente in laboratorio. Come spiega il professor Falini:
“La scoperta di questo marcatore, oggi chiamato CD30, è avvenuta grazie agli anticorpi monoclonali. Il professor Stein cominciò a produrre migliaia di diversi anticorpi monoclonali diretti contro una linea cellulare di Hodgkin; nel 1982, dallo screening di questi anticorpi emerse un clone, in grado di colorare selettivamente le cellule del tumore”.
L’antigene presente sulle cellule Hodgkin a cui si legava l’anticorpo di Stein fu chiamato inizialmente come l’anticorpo stesso, Ki-1, e fu in seguito ribattezzato CD30 seguendo le regole del protocollo Cluster di differenziazione (CD). Come racconta il professore:
“Inizialmente, l’anticorpo Ki-1 poteva essere utilizzato esclusivamente su sezioni di tessuto congelate al criostato. I procedimenti di routine usati negli ospedali, che prevedono la fissazione in formalina e l’inclusione in paraffina, denaturavano infatti la molecola CD30, rendendola invisibile all’anticorpo. Questo rappresentava un limite diagnostico importante. Inoltre, le sezioni congelate non offrivano la definizione morfologica necessaria per un’analisi precisa, che solo i preparati in paraffina possono garantire”.
La collaborazione tra i laboratori di Stein e quello di Falini portò nel 1989 allo sviluppo dell’anticorpo Ber-H2, capace di legarsi al CD30 anche dopo fissazione in formalina e l’inclusione in paraffina. Questo avanzamento migliorò molto l’osservazione morfologica, e permise di usare il CD30 come marcatore diagnostico, non solo per il linfoma di Hodgkin ma anche per altri linfomi caratterizzati da cellule di grande taglia, talora con forme molto bizzarre, che in passato venivano spesso confuse con metastasi di tumori solidi. A questi linfomi che esprimono in abbondanza il CD30 fu assegnato il nome di linfoma anaplastico a grandi cellule (ALCL), entità clinico-patologica poi riconosciuta dalla classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Come sottolinea il professor Falini:
“Identificare un’entità clinico-patologica riconosciuta dall’OMS significa che, se emergono innovazioni terapeutiche, è possibile associare con precisione la risposta a quella determinata malattia”.
Il CD30 come bersaglio terapeutico ideale
Il CD30 ha anche le caratteristiche di un bersaglio terapeutico ideale. Spiega il professore:
“CD30 è espresso sulla superficie delle cellule tumorali, e può quindi essere riconosciuto da anticorpi. Inoltre, è fortemente espresso nelle cellule malate (in particolare nel linfoma di Hodgkin e ALCL), ma è molto raro in quelle sane. Un’altra sua caratteristica è la capacità di essere internalizzato dalle cellule una volta legato all’anticorpo: sfruttando questo meccanismo è possibile introdurre nella cellula un farmaco citotossico”.
La ricerca per trasformare il CD30 in un bersaglio terapeutico iniziò nel 1992, quando il gruppo di Falini sperimentò su pazienti con linfoma di Hodgkin recidivato o refrattario la prima immunotossina anti-CD30, coniugando un anticorpo murino (di topo) anti-CD30 con la saporina, una tossina vegetale. I risultati di Falini furono pubblicati sulla rivista The Lancet, ma il professore ne ricorda i limiti:
“L’anticorpo coniugato con la saporina presentava due problematiche: l’origine murina dell’anticorpo e la forte immunogenicità della saporina, che inducevano la formazione di anticorpi da parte dei pazienti. Potevamo somministrare questa immunotossina soltanto per due volte a distanza di 7 giorni perché poi interveniva la formazione di anticorpi da parte del paziente che impediva il funzionamento del farmaco”.
Dal Brentuximab Vedotin ai nuovi standard BrECADD
Nonostante i limiti, l’idea era valida. Dopo quasi vent’anni dal pionieristico lavoro su The Lancet è stato introdotto in commercio un altro farmaco che aveva lo stesso razionale: il Brentuximab Vedotin (BV). Il BV è un farmaco intelligente che combina un anticorpo umano anti-CD30 con un potente agente citotossico, la Monometil Auristatina E (MMAE). MMAE è un composto molto tossico, ma gli effetti collaterali sono ridotti grazie alla selettività dell’anticorpo, che essendo umanizzato ha una immunogenicità ridotta. Una caratteristica fondamentale alla base dell’efficacia di questo farmaco è l’effetto bystander (effetto in vicinanza): la tossina MMAE può diffondersi attraverso la membrana cellulare per uccidere anche le cellule tumorali vicine che non esprimono il CD30.
Questo percorso ha portato a nuovi standard di cura. Per il Linfoma di Hodgkin classico è stato sviluppato il regime BV-AVD (che esclude la bleomicina e, di conseguenza, riduce la tossicità) che è oggi approvato per l’uso in prima linea. In Italia, l’AIFA ha autorizzato questo protocollo specificamente per i pazienti di età pari o superiore a 60 anni, in stadio IV di malattia e non candidabili all’impiego della bleomicina, dimostrando vantaggi clinici rispetto alla terapia standard ABVD. Per i giovani adulti sotto i 60 anni con linfoma di Hodgkin avanzato, lo studio HD21 del 2024 ha stabilito il regime BrECADD, che combina il BV con etoposide, doxorubicina, ciclofosfamide, dacarbazina e desametasone, come nuovo standard di cura, garantendo una sopravvivenza libera da progressione del 94,3% a quattro anni. Per il ALCL, invece, oggi il BV è impiegato in combinazione con il regime CHP (ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone), sostituendo la vincristina per evitare eccessiva tossicità neurologica. Questo schema si è dimostrato superiore al precedente standard (CHOP) sia nella sopravvivenza libera da progressione che in quella globale. Tale miglioramento è particolarmente evidente nei casi ALK-negativi, che storicamente presentano una prognosi meno favorevole rispetto ai casi ALK-positivi.
Le promesse delle CAR-T anti-CD30
La tecnologia delle cellule CAR-T consiste nel prelevare i linfociti dal malato, ingegnerizzarli in laboratorio affinché riconoscano un bersaglio specifico sulla superficie delle cellule maligne, e reinfonderle nel paziente medesimo.
Il professor Falini spiega che questa strategia ha già rivoluzionato la cura di altri tumori del sangue:
“Le CAR-T anti-CD19 hanno dimostrato una estrema efficacia nel contesto del paziente recidivato o refrattario. Il 30-35% di pazienti con linfomi non-Hodgkin diffusi a grandi cellule B, non responsivi a terapie standard possono oggi essere salvati con questa terapia”.
Nel caso del linfoma di Hodgkin, tuttavia, la situazione è più complessa. Sebbene si riescano a ottenere risultati iniziali incoraggianti, il professore osserva che “si sono osservate risposte complete in questi pazienti, ma si tratta, in genere, di risposte meno durature. E questo si pensa possa essere in un certo senso legato anche all’ambiente immunosoppressivo all’interno del tessuto Hodgkiniano che riduce la risposta alle cellule CAR-T”.
Per superare queste difficoltà, i ricercatori stanno studiando nuove soluzioni per rendere l’attacco al tumore più potente e difficile da eludere: “Stiamo lavorando sull’uso di CAR bispecifiche che possano bersagliare contemporaneamente il CD30 e l’antigene PD-L1, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia. Grazie anche all’ausilio dell’intelligenza artificiale per progettare CAR più precisi, pensiamo che queste terapie avranno in futuro un posto stabile nel trattamento dei pazienti che non rispondono alle cure tradizionali”, conclude il Professor Falini.
L’articolo originale di Stein H, Falini B, CD30 as a Target Molecule in the Diagnosis and Therapy of Lymphomas, pubblicato su Am J Hematol. è disponibile a questo link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41123243/