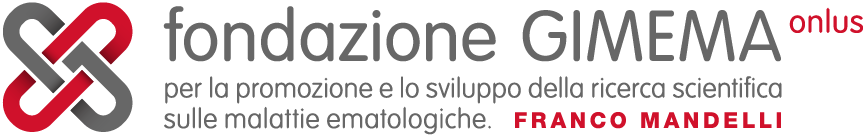L’introduzione degli inibitori della tirosin-chinasi (TKI) ha trasformato la leucemia mieloide cronica da malattia con decorso quasi sempre fatale in una condizione cronica con sopravvivenze simili a quelle delle persone sane. L’integrazione di nuovi TKI e strategie di riduzione della tossicità potrebbero ulteriormente migliorare il decorso della malattia.
La leucemia mieloide cronica (CML, dall’acronimo inglese Chronic Myeloid Leukemia) è una neoplasia che colpisce le cellule staminali ematopoietiche del midollo osseo – quelle che danno origine a globuli bianchi, globuli rossi e piastrine – inducendole ad una crescita incontrollata. Ad oggi, l’incidenza della malattia è di circa 2 casi ogni 100.000 persone. La quasi totalità delle forme di CML presenta il cosiddetto cromosoma Philadelphia (Ph), derivante da un riarrangiamento di materiale genetico tra i cromosomi 9 e 22. Questa traslocazione cromosomica porta alla formazione del gene di fusione BCR::ABL1 dal quale, a sua volta, ha origine la proteina responsabile della crescita tumorale. A livello globale, si stima siano circa 5 milioni i pazienti affetti la CML. In un articolo di revisione, pubblicato di recente sulla rivista Cancer, gli autori esplorano l’evoluzione delle strategie per il trattamento della leucemia mieloide cronica e le sfide future alle quali si sta lavorando.
La gestione della leucemia mieloide cronica dall’era pre-TKI all’impatto rivoluzionario dei TKI
Prima del 2000, le terapie disponibili per la CML erano limitate a farmaci citotossici (busulfano, idrossiurea) e all’interferone-α, ed avevano efficacia modesta e significativa tossicità. L’interferone-α veniva somministrato con iniezioni sottocutanee giornaliere e migliorava la sopravvivenza mediana da 3–4 anni a 5–6 anni.
Il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT, Haematopoietic Stem Cell Transplantation) rappresentava l’unica opzione curativa, con una sopravvivenza a 20 anni di circa il 40%, quando eseguito precocemente nella fase cronica della malattia.
L’introduzione degli inibitori della tirosin-chinasi BCR::ABL1 nel 2000 ha segnato un punto di svolta: la sopravvivenza globale a 10 anni è passata da meno del 10% a oltre l’80%. Difatti, i TKI hanno trasformato una malattia dal decorso quasi sempre fatale in una con una prognosi quasi sempre eccellente.
Panorama attuale dei TKI
Nel 2025, sei TKI sono approvati per la LMC: imatinib, dasatinib, bosutinib, nilotinib, ponatinib e asciminib.
- Imatinib è considerato un TKI di prima generazione.
- Dasatinib, bosutinib e nilotinib appartengono alla seconda generazione, di più recente sviluppo, e sono caratterizzati da maggiore potenza e rapidità di risposta.
- Ponatinib e asciminib, sono invece considerati TKI di terza generazione, e rappresentano un’opzione efficace nei casi con mutazione T315I, nota come “gatekeeper“, che conferisce resistenza sia all’imatinib che ai TKI di seconda generazione.
Oltre ai TKI già approvati e in fase di commercio, sono in fase di sviluppo ulteriori molecole, come olverembatinib, ELVN-001, TGRX-678 e TERN-701. Inoltre, l’ampia disponibilità dei TKI generici di prima e alcuni di seconda generazione, ha ridotto i costi del trattamento, rendendoli accessibili anche nei paesi con risorse più limitate.
L’efficacia della terapia con I TKI: DMR e TFR
A 25 anni dall’introduzione dell’imatinib, i dati dimostrano che l’impatto dei TKI sul decorso della CML è duraturo e sostenuto. La remissione libera da trattamento (TFR, Treatment-Free Remission), ovvero l’interruzione della terapia con TKI senza recidiva della malattia, è un obiettivo realistico nel trattamento della leucemia mieloide cronica. In particolare, la presenza di una risposta molecolare profonda (DMR, Deep Molecular Response), ovvero uno stato clinico in cui il livello del biomarcatore della malattia (il trascritto BCR-ABL) scende a livelli non rilevabili, aumenta le probabilità di TFR fino all’80% se sostenuta per oltre due anni. I nuovi TKI portano a un raggiungimento più precoce delle DMR durature. Tuttavia, le terapie di seconda generazione presentano un rischio maggiore di eventi avversi rispetto a imatinib, con tassi di interruzione del trattamento tra il 12 e il 25%.
Nuove strategie per la riduzione della tossicità
Il miglioramento del trattamento della leucemia mieloide cronica ha permesso la cronicizzazione della malattia, rendendola più facilmente gestibile. Contestualmente, ha fatto emergere problematiche legate alla comparsa di effetti indesiderati nel lungo periodo, soprattutto cardiovascolari. Per cui, sono in fase di sperimentazione nuove strategie per la riduzione della tossicità. Tra queste, si sta mettendo a punto la dose biologicamente ottimale (OBD, Optimal Biological Dose), ovvero una dose che presumibilmente mantiene la stessa efficacia terapeutica della massima tollerata, che è quella tradizionalmente usata, ma che riduce significativamente le tossicità a breve e lungo termine. Alternative alla riduzione della dose, ancora in fase di studio, sono la somministrazione intermittente dei TKI e la de-escalation del trattamento.
Quando ricorrere al trapianto nella leucemia mieloide cronica
Con l’introduzione dei TKI, il trapianto allogenico di cellule staminali è diventato un’opzione alla quale si ricorre raramente e solo in determinate condizioni: è riservato a pazienti con progressione in fase avanzata, resistenza ai TKI di seconda generazione o mutazioni ad alto rischio, come la T315I. Pur essendo il trapianto un trattamento curativo e meno costoso sul lungo periodo, il suo impiego è limitato dai rischi di mortalità e complicanze gravi. La scelta va quindi personalizzata, bilanciando benefici e rischi rispetto ai TKI.
L’articolo originale di Kantarjian H, et al., Management of chronic myeloid leukemia in 2025, pubblicato su Cancer è disponibile al seguente link https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.35953?campaign=woletoc