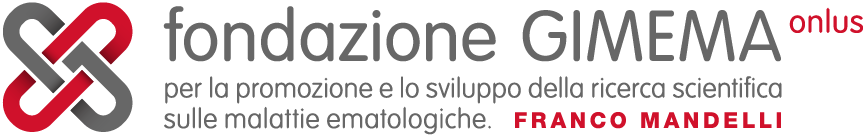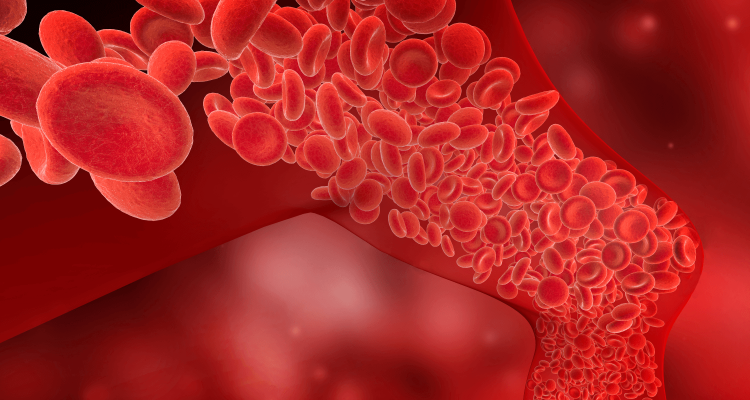La strategia terapeutica con ropeginterferone nella policitemia vera (PV) va calibrata sul profilo biologico del paziente: le evidenze attuali non giustificano un’escalation generalizzata del dosaggio. Sono le osservazioni contenute in una lettera pubblicata sul British Journal of Haematology.
L’approvazione del ropeginterferon alfa-2b (Ropeg) ha rappresentato una svolta nel trattamento della policitemia vera (PV): per la prima volta, un interferone pegilato veniva autorizzato da EMA e FDA per l’uso specifico in questa patologia. Ma a distanza di alcuni anni dall’introduzione del farmaco, si apre una nuova questione clinica: quale dosaggio è davvero ottimale? È opportuno spingere subito su dosi elevate per ottenere una risposta molecolare rapida, soprattutto nei pazienti a “basso rischio”?
Una lettera pubblicata sul British Journal of Haematology su iniziativa di Tiziano Barbui, ematologo alla Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo – FROM, e condivisa dai colleghi Ayalew Tefferi (Mayo Clinic Rochester) e Alessandro Vannucchi (Università degli Studi di Firenze) solleva dubbi sull’applicazione estensiva di dosaggi elevati, oggi proposti da diversi gruppi di ricerca.
La lettera cita in particolare i risultati pubblicati lo scorso ottobre sulla stessa rivista da Shanshan Suo e colleghi, che hanno sperimentato un incremento rapido del dosaggio del farmaco fino a 500 microgrammi già dalla quarta settimana, ottenendo un’ottima risposta molecolare nei pazienti. Secondo alcuni ricercatori, questa strategia ad alte dosi potrebbe portare benefici superiori, ma per Barbui è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, e non bisogna ignorare i dati che puntano in un’altra direzione.
“Abbiamo scritto questa lettera perché si stava diffondendo un entusiasmo un po’ acritico per i regimi ad alto dosaggio”, spiega. “Ma non tutti i pazienti hanno bisogno di una risposta molecolare rapida, né è detto che questa si traduca in un vantaggio concreto nel lungo periodo”.
La mutazione JAK2 V617F e la risposta molecolare
La PV è caratterizzata nella maggior parte dei casi da una mutazione acquisita del gene JAK2 (V617F), che induce una produzione eccessiva e continua di cellule del sangue da parte del midollo osseo. Questo aumento determina non solo un rischio trombotico, ma nel tempo, può favorire la progressione verso forme più gravi come mielofibrosi o leucemia acuta.
Per anni, il farmaco di riferimento nella policitemia vera è stato l’idrossiurea, utilizzata soprattutto nei pazienti ad alto rischio trombotico. Questo chemioterapico orale agisce riducendo rapidamente i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, riportandoli entro valori normali. Tuttavia, non modifica la base genetica della malattia: non ha effetto sul clone JAK2 mutato, né incide sulla progressione a lungo termine.
“Con l’idrossiurea si può normalizzare l’emocromo, ma non si tocca la base genetica della malattia. L’interferone invece può ridurre stabilmente il carico della mutazione JAK2, ma occorre tempo, e non necessariamente dosi alte per farlo”, sottolinea Barbui.
L’efficacia del ropeginterferon risiede nella sua capacità di ridurre nel tempo la quantità di cellule che portano la mutazione JAK2, misurata attraverso un parametro molecolare chiamato VAF (Variant Allele Frequency). Il ropeginterferone si pone dunque come una terapia con potenziale “disease-modifying”, capace di modificare la storia naturale della malattia, soprattutto nei pazienti più giovani o con maggiore aspettativa di vita.
Tuttavia, secondo Barbui non è necessario forzare i tempi di questa riduzione.
“La policitemia vera non è una leucemia acuta. È una malattia cronica che evolve nel giro di decenni. Raggiungere subito il minimo livello possibile di mutazione non è sempre necessario, e può esporre il paziente a più effetti collaterali e a un maggior costo sociale”.
Dosi fisse e risposte sostenibili
Nel 2021 Barbui ha pubblicato sulla rivista The Lancet Haematology i risultati del primo studio che ha utilizzato ropeginterferone in pazienti a basso rischio trombotico, storicamente trattati solo con la salassoterapia. Una precisazione importante, però, riguarda proprio la definizione di basso rischio, che Barbui invita a usare con cautela: “È una definizione relativa, basata sul rischio trombotico. Ma non significa che questi pazienti abbiano una forma lieve di malattia. Anche loro possono andare incontro, nel tempo, a mielofibrosi, leucemia o altre complicanze evolutive”, precisa.
Per quanto riguarda i salassi, ovvero prelievi regolari di sangue per ridurre la massa eritrocitaria e la viscosità ematica, la loro funzione è appunto quella di abbassare velocemente il rischio trombotico.
“Un paziente con policitemia può avere fino a 7 litri di sangue, contro i 4 o 5 litri normali. Questo sovraccarico mette sotto pressione il cuore e aumenta il rischio di eventi come infarti o ictus. Il salasso è un trattamento che riduce immediatamente questi rischi”, spiega Barbui.
Il regime sperimentato da Barbui e colleghi prevedeva 100 microgrammi del farmaco ogni due settimane a dose fissa, senza incrementi. Dopo 12 mesi, oltre l’80% dei pazienti ha raggiunto una risposta ematologica completa, contro il 51% del gruppo trattato solo con i salassi. La riduzione del VAF JAK2 è stata lenta ma costante, e si è mantenuta nel tempo, come mostrato nel follow-up pubblicato successivamente su NEJM Evidence.
“Con le dosi basse abbiamo ottenuto la stessa riduzione della mutazione che si osserva con le dosi più alte, semplicemente ci si arriva più lentamente”, spiega Barbui. “Ma in una malattia che si misura in decenni, la gradualità è un vantaggio, non uno svantaggio”.
A supporto di questo approccio, Barbui ricorda anche che lo schema a dose fissa è più tollerabile per il paziente e più sostenibile per il sistema sanitario. In uno studio condotto in collaborazione con AOP Orphan, l’azienda che ha sviluppato il farmaco, è stato calcolato che in Austria il trattamento con 100 microgrammi ogni due settimane costa circa 50.000 euro l’anno per paziente. Un dosaggio più alto, fin dall’inizio, raddoppierebbe il costo senza un chiaro vantaggio clinico.
Verso una medicina più personalizzata
Il punto è che non tutti i pazienti hanno la stessa forma di PV, né lo stesso rischio evolutivo. Alcuni, come ha mostrato Barbui in altri studi, i pazienti possono essere stratificati anche in base a marcatori infiammatori come il rapporto neutrofili-linfociti (NLR). Un valore superiore a 3,5 sembra indicare una forma più attiva e potrebbe guidare la scelta verso dosi più alte di interferone.
“Ci sono pazienti che ottengono ottimi risultati con 100 microgrammi, altri che forse necessitano di dosi più elevate. Ma questi sono casi selezionati, e devono essere gestiti individualmente”, chiarisce Barbui.
Attualmente sono in corso studi clinici come PARADIGM-PV ed ECLIPSE, che analizzeranno più a fondo i benefici dei diversi dosaggi. Ma Barbui invita alla cautela.
“Finché non avremo studi a lungo termine, è prematuro inseguire la risposta molecolare a tutti i costi”, afferma. “Serve equilibrio: rispetto per il paziente, attenzione ai costi e un uso intelligente di uno strumento potente, che però va maneggiato con criterio”.
La lettera pubblicata sul British Journal of Haematology è disponibile a questo link: https://doi.org/10.1111/bjh.19996