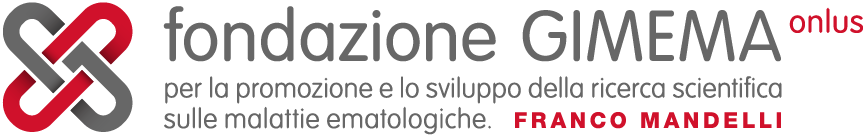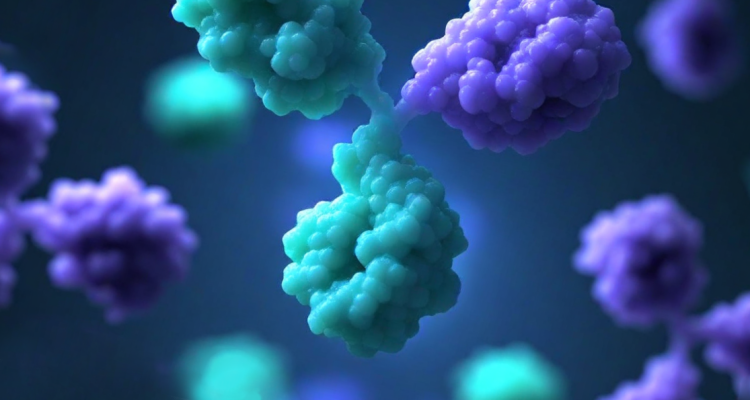Lo studio GIMEMA LAL2317 mostra che introdurre precocemente l’immunoterapia con il blinatumomab migliora i tassi di malattia minima residua e di sopravvivenza nella leucemia linfoblastica acuta Philadephia negativa a cellule B.
In un’epoca in cui la medicina di precisione sta riscrivendo le regole dell’oncologia, anche la gestione della leucemia linfoblastica acuta a cellule B cerca nuovi approcci. Un nuovo studio, pubblicato su Blood, riporta i risultati del protocollo GIMEMA LAL2317 nella Ph− B-ALL, la forma Philadelphia-negativa della leucemia linfoblastica acuta a cellule B. E mostra come la somministrazione precoce del blinatumomab, un anticorpo bispecifico che si comporta come un “ponte” che avvicina le cellule T alle cellule tumorali, causandone poi la distruzione, possa avere una differenza significativa nel trattamento della patologia.
Ci racconta questo lavoro Renato Bassan, primo autore dello studio e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’Ospedale dell’Angelo di Venezia-Mestre.
Il protocollo GIMEMA LAL2317
La Ph− B-ALL è un tumore maligno che colpisce i linfoblasti B, le cellule immature del sistema immunitario. È una malattia aggressiva, con un elevato rischio di recidive, che richiede un trattamento tempestivo. “Il blinatumomab è un anticorpo noto da almeno una decina d’anni e che ha già mostrato un’efficacia importante nelle fasi di recidiva, resistenza e persistente malattia residua minima (Minimal Residual Disease, MRD)”, spiega l’ematologo. “In particolare, la sfida del nuovo lavoro è stata trasferirlo nella terapia iniziale”.
Il nuovo studio ha seguito 149 pazienti di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il protocollo prevedeva un trattamento chemioterapico di prima linea, e, dopo il terzo e il sesto ciclo di chemioterapia, l’impiego di due cicli di blinatumomab endovenoso.
“Il principale obiettivo clinico (endpoint primario) dello studio era la valutazione del tasso di negativizzazione della MRD”, spiega ancora Bassan.
“La MRD indica la presenza di cellule leucemiche residue non rilevabili con l’osservazione al microscopio, ma identificabili con tecniche molecolari ad alta sensibilità. In altre parole, valutare la MRD è come cercare le ultime cellule tumorali occulte dopo che il paziente ha raggiunto la remissione clinica; rappresenta un fondamentale fattore prognostico per la Ph− B-ALL (e per altre neoplasie ematologiche)”.
I risultati del protocollo
Prima del trattamento con blinatumomab, il 72% dei pazienti con leucemia linfoblastica acuta Ph− a cellule B era MRD-negativo, privo di cellule tumorali residue; dopo il primo ciclo di trattamento con l’anticorpo, la percentuale è salita al 93%. Un risultato molto positivo e che può essere letto anche in un altro modo: dei pazienti MRD-positivi, il 73% si è negativizzato dopo il trattamento.
Il gruppo di ricerca ha raccolto anche altri dati, tra cui quelli relativi alla sopravvivenza a tre anni: globalmente pari al 71%, e si incrementa all’82% nelle persone trattate con blinatumomab. Inoltre, la sopravvivenza libera da malattia risultava del 65%, e con percentuali significativamente maggiori (92%) nelle persone più giovani e con MRD negativa precoce.
“In termini generali, questi sono risultati molto positivi”, commenta Bassan. Che precisa, comunque, la necessità di ampliare i risultati con ulteriori e più ampi studi per confermare e strutturare al meglio i dati.
A questo proposito, vale la pena fare una nota. L’attuale studio ha coinvolto un numero relativamente limitato di pazienti (anche se è importante considerare che la Ph− B-ALL è una neoplasia piuttosto rara), ma moltissimi centri di studio italiani. È un elemento che indica come il protocollo abbia potuto essere applicato anche in centri con pochi pazienti, a suggerire una possibile replicabilità pressocché ovunque, senza la necessità di strutture specifiche e difficilmente reperibili.
“L’aggiunta dell’immunoterapia nel trattamento di queste neoplasie sta dando risultati importanti: per questo ora si cerca di sfruttare appieno questi farmaci, integrandoli nel trattamento di prima linea e magari riducendo la necessità di chemioterapia intensiva e trapianti, se ciò sarà dimostrato possibile; tanto più che il blinatumomab è in generale ben tollerato”, conclude l’ematologo. “In questo contesto, inoltre, dovremo concentrarci sulle persone con i fattori prognostici più sfavorevoli, per identificare strategie terapeutiche più efficaci”.