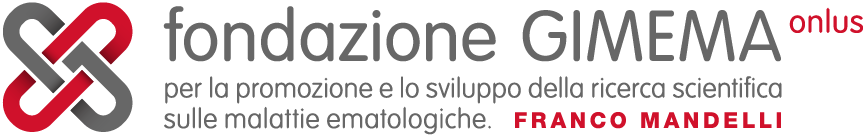La prima analisi ad interim dello studio che osserva l’utilizzo e gli esiti clinici del ruxolitinib nella pratica clinica in Italia, evidenzia come un dosaggio non ottimale sia frequente e possa ridurre l’efficacia del trattamento, con un impatto negativo sulla prognosi dei pazienti affetti da mielofibrosi
La mielofibrosi è una neoplasia mieloproliferativa cronica in cui si verifica una proliferazione di cloni cellulari alterati che stimolano una produzione eccessiva di fibre di collagene all’interno del midollo che, subendo una trasformazione fibrotica, altera la normale produzione delle cellule del sangue. La malattia può manifestarsi senza cause precedenti, oppure può insorgere come evoluzione di altre malattie del sangue, come la trombocitemia essenziale o la policitemia vera.
I pazienti affetti da mielofibrosi presentano sintomi come ingrossamento progressivo della milza, trombosi, sanguinamenti o infezioni; nei casi più avanzati, la malattia può peggiorare fino a determinare una insufficienza del midollo osseo o evolvere in una forma più aggressiva, la leucemia mieloide acuta. Si tratta di una patologia che ha un impatto importante sia sulla sopravvivenza sia sulla qualità della vita dei pazienti, per la quale, nella maggior parte dei casi, l’obiettivo terapeutico è alleviarne i sintomi, migliorare la qualità della vita e prolungare la sopravvivenza complessiva.
L’uso di ruxolitinib nella mielofibrosi
Molecole come il ruxolitinib si inseriscono in questo contesto. Attualmente, l’uso di questo farmaco è oggetto di analisi nello studio prospettico ROMEI, che ne valuta gli esiti nella pratica clinica in Italia. Ne abbiamo discusso con Francesca Palandri e Francesco Passamonti, rispettivamente prima e ultimo autore di un recente articolo pubblicato sulla rivista Cancer, in cui vengono presentati i risultati intermedi dello studio clinico.
Ma cos’è il ruxolitinib e come funziona? Questo farmaco è un inibitore della chinasi JAK, un enzima implicato nella via di segnalazione cellulare JAK-STAT, che regola la crescita e la sopravvivenza delle cellule. Una delle scoperte più importanti riguardo le basi genetiche e molecolari della mielofibrosi, è stata infatti, nei primi anni 2000, una mutazione a carico della via JAK-STAT che favoriva una proliferazione incontrollata delle cellule del sangue: questo ha permesso lo sviluppo di farmaci in grado di bloccare la via di segnalazione difettosa. Il primo a essere approvato è stato proprio il ruxolitinib, che si è rivelato un efficace alleato per il trattamento della mielofibrosi, in particolare nella riduzione del volume della milza e nel miglioramento dei sintomi, contribuendo ad aumentare la sopravvivenza globale dei pazienti.
L’efficacia del trattamento con ruxolitinib dipende anche dalla dose somministrata e che, in genere, viene stabilita in base alla conta piastrinica del paziente all’inizio della terapia. “Tuttavia, studi osservazionali hanno indicato che molti pazienti ricevono il farmaco a dosaggi inferiori rispetto a quelli previsti in base alla conta piastrinica. Lo studio ROMEI nasce per indagare come il ruxolitinib sia stato utilizzato nel contesto italiano”, raccontano a GIMEMA Informazione gli autori dell’articolo.
Lo studio ROMEI
ROMEI è uno studio prospettico, osservazionale, multicentrico e tuttora in corso, condotto in 51 centri ematologici di tutto il territorio italiano che ha coinvolto 508 pazienti affetti da mielofibrosi trattati con ruxolitinib tra il 2017 e il 2022. Il follow-up dei pazienti è previsto fino a cinque anni. L’articolo pubblicato su Cancer ha esaminato i pazienti che avevano completato i primi 12 mesi, analizzando i dosaggi del ruxolitinib e i relativi esiti clinici. “La forza dello studio, rispetto ai precedenti dati, è nella sua natura prospettica, nel monitoraggio esterno che garantisce un’elevata qualità dei dati raccolti, nel rispetto della libertà decisionale degli ematologi: in questo modo è possibile catturare un contesto di real-life”, aggiungono i ricercatori.
Dallo studio emerge che il 43% dei pazienti ha iniziato il trattamento con una dose inferiore al previsto. Questo – sottolineano Palandri e Passamonti – è stato particolarmente evidente nella coorte di pazienti più anziani e con anemia di grado moderato-severo e/o con piastrinopenia. Tale dato rappresenta un problema.
“In primis, perché un dosaggio iniziale subottimale si associa a una inadeguata efficacia terapeutica, e in più perché è correlato con una maggiore probabilità di sospensione della terapia, che sappiamo essere a sua volta associata a una prognosi sfavorevole, e con un aumentato rischio di mortalità”.
Inoltre, i pazienti che non ricevono un dosaggio ottimale di ruxolitinib tendono a presentare un miglioramento meno marcato dei sintomi, anche se il farmaco si è dimostrato efficace nel controllare la sintomatologia a dosi più basse.
In generale, quindi, con il ruxolitinib si registra comunque un incremento della qualità della vita nei pazienti, ma i benefici sono più evidenti in quelli che assumono il dosaggio ottimale.
Questa prima analisi dello studio ROMEI, quindi, conferma quanto sia importante un dosaggio adeguato di ruxolitinib per garantire la massima efficacia del trattamento, una migliore sopravvivenza e un profilo di sicurezza gestibile. “Questi dati sono importanti per educare medici e pazienti a una corretta gestione del farmaco, volta a mantenere in tutti i pazienti il massimo dosaggio consentito. In futuro, studi clinici controllati potrebbero indagare una personalizzazione del dosaggio in base a specifiche caratteristiche cliniche”, concludono i ricercatori.
L’articolo scientifico di Breccia M, Palandri F et al, Dosing and clinical outcomes of ruxolitinib in patients with myelofibrosis in a real-world setting: Interim results of the Italian observational study (ROMEI), pubblicato su Cancer, è disponibile a questo link: https://doi.org/10.1002/cncr.35801