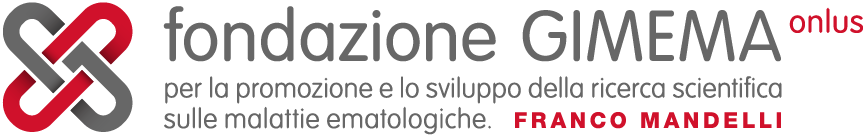Chi è affetto da linfoma a grandi cellule B e presenta comorbidità è spesso escluso dalla terapia CAR-T per timori di tossicità. Ma uno studio bicentrico condotto tra Roma e Parigi mostra che anche i pazienti “fragili” possono affrontare il trattamento con sicurezza simile alle altre persone
Ci sono terapie che sembrano fatte su misura per poche persone: quelle giovani, forti, senza altre malattie. Ma cosa succede quando a bussare alla porta della medicina più innovativa sono i pazienti definiti “fragili”?
Uno studio pubblicato sul British Journal of Haematology riapre il dibattito sull’accesso alla CAR-T, un trattamento di immunoterapia usato per alcune neoplasie ematologiche, tra cui il linfoma a grandi cellule B (LBCL, dall’acronimo inglese Large B-Cell Lymphoma), e mostra che anche chi convive con più patologie può affrontarlo senza rischi aggiuntivi.
Ne abbiamo parlato con il primo autore, Eugenio Galli, ematologo della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
I dubbi emergenti sulla CAR-T
La CAR-T è ormai diventata lo standard di trattamento per molti tumori ematologici, come le leucemie, i linfomi e, più recentemente, il mieloma multiplo. Si basa sulla modifica genetica di cellule T prelevate al paziente, in modo che possano esprimere un recettore chiamato CAR (Chimeric Antigen Receptor), che permette loro di riconoscere e attaccare le cellule tumorali. Per esempio, nei linfomi, il CAR è programmato per riconoscere il marcatore CD19 presente sulle cellule tumorali B. Quindi, le cellule sono moltiplicate in laboratorio e reinfuse nel paziente.
Questo approccio ha offerto una possibilità di cura che fino pochi anni fa sarebbe stata impensabile. “Ma, dopo l’entusiasmo iniziale, sono iniziati a emergere alcuni dubbi importanti sulla sicurezza della terapia CAR-T. Se inizialmente sembrava meno tossica rispetto al trapianto autologo, che rappresentava la principale opzione di cura per persone con LBCL con recidiva o che non rispondevano alla chemioterapia, la mortalità della CAR-T è arrivata a essere simile se non superiore”, spiega Galli. “Le principali cause di mortalità non legata a recidiva associate alla terapia sono infezioni, sindrome da rilascio di citochine (una risposta infiammatoria sistemica causata da un’attivazione massiccia del sistema immunitario), neurotossicità, eventi cardiovascolari e neoplasie secondarie, in particolare leucemia mieloide acuta e sindromi mielodisplastiche”.
Da qui, i crescenti studi sulla sicurezza della terapia CAR-T, focalizzati, però, soprattutto sulle cause di mortalità non legata a recidiva e poco sul ruolo delle comorbidità cliniche. Almeno in parte, questo dipende dalla stringente selezione dei pazienti che possono accedere alla terapia, e da cui sono spesso escluse le persone più fragili. Ma questo tipo di selezione può essere considerato valido?
Mettere alla prova il ruolo delle comorbidità
Per rispondere al quesito, un nuovo studio ha analizzato l’impatto delle comorbidità pre-esistenti sulla sicurezza e la mortalità non legata a recidiva della CAR-T, basandosi su tre diversi indici: CIRS – Cumulative Illness Rating Scale, Severe 4 e Hematopoietic Cell Transplantation–Comorbidity Index (HCT-CI).
“CIRS è derivato dal mondo geriatrico: nasce quindi per valutare la fragilità del paziente anziano, ragione per cui ha una visione complessiva che tende un po’ a perdersi nel mondo oncologico. Infatti considera 14 sistemi d’organo dando a ciascuno la stessa importanza: quindi, per esempio, un danno cardiaco ‘vale’ quanto un problema alla vista”, spiega Galli. “Severe4 è una sottoselezione del CIRS, focalizzata su quattro sistemi d’organo critici per la tolleranza ai trattamenti oncologici. HCT-CI, infine, è un indice sviluppato per prevedere il rischio di complicanze e mortalità nei pazienti candidati a trapianto di cellule staminali emopoietiche. È simile al CIRS come architettura, ma valuta 14 categorie di comorbidità (come malattie cardiache, epatiche, diabete, infezioni attive etc…), dando privilegio agli organi che più impattano sul trapianto”.
I dati sono stati raccolti su un vasto campione di 379 pazienti trattati con CAR-T in due centri europei, Roma e Parigi, tra il 2018 e il 2024; il gruppo di ricerca ha indagato quanto ciascuno dei diversi indici riuscisse a predire la mortalità non dovuta a recidiva e le tre principali tossicità dovute alla terapia: la sindrome da rilascio di citochine, la sindrome neurotossica associata a cellule effettrici immuni e la tossicità ematologica associata a cellule effettrici immuni. “Inoltre, abbiamo cercato di capire se i pazienti con più comorbidità avessero un maggior bisogno di trattamenti di supporto, come misura indiretta della gravità delle tossicità e la tollerabilità clinica del trattamento”, continua Galli.
Frail is not fail
I risultati dell’analisi sono ben riassunti dall’espressione che titola lo studio: frail is not fail, la fragilità non implica un fallimento.
In altre parole, non vi è differenza di mortalità tra i pazienti che gli indici rilevano come più o meno a rischio.
“Va poi osservato che gli indici non sono coerenti l’uno con l’altro nei risultati: il livello di rischio cambia a seconda dell’indice usato. Questo non modifica comunque il risultato principale: circa un terzo dei pazienti poteva essere considerato ‘fragile’, ma ciò non ha aumentato il rischio di tossicità severa né la mortalità non dovuta a recidiva”, precisa l’ematologo. Anche i trattamenti di supporto sono risultati simili tra pazienti ‘fragili’ e non fragili, a conferma che le comorbidità non aumentano il rischio di tossicità severa o di maggiore bisogno di cure intensive.
L’implicazione diretta è, quindi, che i criteri di eleggibilità della terapia CAR-T, ovviamente rimanendo nei limiti indicati dagli enti regolatori, potrebbero essere ampliati anche a persone finora rimaste escluse proprio a causa delle loro comorbidità.
“Anche gli accorgimenti che stiamo imparando ad applicare, come l’uso precoce di trattamenti di supporto, contribuiscono a consentire, anche ai pazienti a maggior rischio, di affrontare la terapia”, spiega Galli. “Naturalmente, la scelta deve essere condivisa con il paziente, senza essere presa a priori dal curante”.
“Questo tipo di studio potrebbe senz’altro essere esteso ad altre terapie. In particolare, mancano informazioni sulla ‘sorella’ della CAR-T, l’immunoterapia con anticorpi bispecifici, che sarebbe particolarmente importante da valutare proprio perché ritenuta opzione più sicura, tanto che gli enti regolatori non prevedono limiti di età per il suo accesso”, conclude l’ematologo. “Ma ancora più urgente sarebbe validare la nostra casistica anche per le CAR-T usate per altre forme tumorali, così da capire se ci sono persone che dovrebbero essere escluse, o viceversa, evitare di escludere persone che potrebbero beneficarne”.
L’articolo originale di Galli E, et al., LETTER: Frail is not fail: Limited impact of comorbidities on non-relapse mortality and safety in patients with LBCL treated with CAR-T, pubblicato sul British Journal of Haematology è disponibile al seguente link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.20222?campaign=wolearlyview