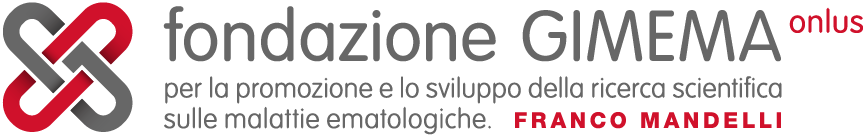Una recente revisione pubblicata sulla prestigiosa rivista American Journal of Hematology passa in rassegna le terapie oggi disponibili per il trattamento della mielofibrosi, una malattia caratterizzata da fibrosi midollare, splenomegalia, anemia, sintomi sistemici debilitanti e un rischio variabile di evoluzione leucemica.
La mielofibrosi (MF) è una neoplasia mieloproliferativa cronica che può insorgere primariamente o come evoluzione di altre patologie come la policitemia vera o la trombocitemia essenziale. Il trattamento di questa malattia per anni è variato dalla sola osservazione, nel caso di pazienti asintomatici e a basso rischio, al trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche in pazienti selezionati. Il trapianto allogenico, ancora oggi, rappresenta l’unico trattamento potenzialmente curativo. In una recente revisione pubblicata sulla prestigiosa rivista American Journal of Hematology, i ricercatori Giuseppe Loscocco e Paola Guglielmelli, del Centro di Ricerca e Innovazione per le Malattie Mieloproliferative (CRIMM) di Firenze, hanno analizzato e discusso le varie opzioni terapeutiche, con un particolare focus sulle nuove terapie mirate.
La prima grande svolta nel panorama terapeutico della mielofibrosi si è avuta grazie alla scoperta della presenza, in oltre il 90% dei pazienti, di mutazioni a carico delle proteine JAK2, CALR o MPL che ha portato allo studio e al successivo sviluppo di inibitori della JAK chinasi (JAKi), primo fra tutti il ruxolitinib. Questo farmaco si è rivelato in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti ma non di modificare la storia naturale della malattia.
Ruxolitinib e, successivamente, fedratinib, pacritinib e momelotinib hanno mostrato efficacia nel ridurre il volume della splenomegalia e nell’attenuare i sintomi sistemici; tuttavia, nessuno di questi farmaci è in grado di prolungare significativamente la sopravvivenza del paziente o di modificare la progressione della malattia, e circa la metà dei pazienti sospende il trattamento entro tre anni.
Giuseppe Loscocco ha spiegato: “Negli ultimi anni, il panorama terapeutico si è ampliato includendo tre JAK inibitori attualmente disponibili in Italia. In particolare, il momelotinib non solo agisce sui sintomi sistemici e sulla splenomegalia, ma ha anche dimostrato di migliorare l’anemia mediante l’inibizione della proteina ACVR1 (recettore 1 dell’activina). Questa inibizione modula i livelli di epcidina e ferro nell’organismo, stimolando così l’eritropoiesi, ovvero il processo di produzione dei globuli rossi”.
I limiti della terapia con JAKi hanno portato i ricercatori, negli ultimi anni, ad un’intensa attività di studio al fine di individuare terapie sempre più mirate. Le nuove strategie si sono focalizzate su bersagli alternativi, mirando a modificare il decorso della malattia, non solo a ridurne i sintomi.
Alcuni farmaci promettenti, oggetto di studio negli anni, sono:
- i BET-inibitori come il pelabresib che agisce su meccanismi epigenetici, riducendo infiammazione e fibrosi e, in associazione a ruxolitinib, ha mostrato ottimi risultati;
- i LSD1-inibitori, come bomedemstat e PRMT5-inibitori, che agiscono a livello epigenetico e hanno mostrato attività promettenti anche sulla fibrosi midollare;
- imetelstat, un inibitore della telomerasi ancora in sperimentazione, che ha mostrato un possibile impatto sulla sopravvivenza in pazienti refrattari a JAKi;
- inibitori del ciclo cellulare e pro-apoptotici, come navitoclax (anti-BCL-2/BCL-xL) e alisertib (inibitore di Aurora A) che puntano a indurre la morte delle cellule neoplastiche. Il navitoclax, in particolare, ha mostrato riduzioni della fibrosi in oltre il 30% dei pazienti e risposte sintomatiche nel 30% dei casi, ma si accompagna ad una tossicità ematologica che ne ha limitato il suo ulteriore sviluppo.
Altre terapie più innovative e forse ancora futuristiche per la mielofibrosi, sono rappresentate dagli anticorpi monoclonali (es. INCA033989) o da quelle che si avvalgono di un utilizzo mirato del nostro stesso sistema immunitario come vaccini terapeutici e persino cellule CAR-T dirette contro mutazioni di CALR.
Il progresso e l’impegno nella ricerca di nuove terapie sono stati ribaditi anche da Loscocco stesso, che ha aggiunto: “Numerosi farmaci sono attualmente in fase di sperimentazione, sia come monoterapia che in combinazione; alcuni risultati appaiono incoraggianti, ma la sfida nell’identificazione di nuovi bersagli terapeutici efficaci e specifici rimane aperta”.
Ad oggi, purtroppo, l’unico trattamento potenzialmente curativo resta il trapianto allogenico di cellule staminali, riservato a una minoranza selezionata di pazienti.
I JAKi sono efficaci nel controllare i sintomi sistemici della malattia, ma non ne modificano l’evoluzione. Si rendono necessari, quindi, lo studio di nuovi potenziali target terapeutici, l’introduzione di ulteriori parametri biologici e la formulazione di nuovi obiettivi terapeutici che vadano a superare la sola riduzione dei sintomi e mirino ad un prolungamento della sopravvivenza e al controllo di altri importanti aspetti della malattia, come la progressione della fibrosi midollare. La speranza dei ricercatori per il trattamento della mielofibrosi è riposta nelle nuove combinazioni di terapie mirate, nella target therapy mutazione-specifica, e nell’arrivo di immunoterapie personalizzate. Con un approccio più individuale, il futuro potrebbe finalmente portare a cure più efficaci, durature e personalizzate per i pazienti affetti da questa patologia complessa.
È possibile leggere la revisione di Giuseppe G. Loscocco e Paola Guglielmelli a questo link: https://doi.org/10.1002/ajh.27658