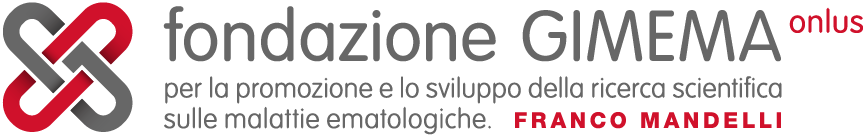La combinazione di venetoclax e rituximab è tra le strategie terapeutiche in corso di studio per la cura dei pazienti giovani con leucemia linfatica cronica. I risultati aggiornati del trial clinico GIMEMA sono stati appena presentati al congresso ASH2023 dell’American Society of Hematology in California.
“La sopravvivenza dopo una diagnosi leucemia linfatica cronica dipende dall’età dei pazienti, ma anche dal loro profilo biologico. La presenza di un particolare assetto genetico può infatti determinare una prognosi più sfavorevole in termini sia di durata di vita, che di risposta alle terapie”, spiega Francesca Romana Mauro, medico e ricercatrice presso il dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione della Sapienza di Roma. In collaborazione con una trentina di centri clinici distribuiti in tutta Italia, ha lavorato al trial clinico di fase 2, LLC1518 VERITAS, che ha sperimentato su questo tipo di pazienti il trattamento con venetoclax e rituximab. Quest’ultimo farmaco è utilizzato da molti anni nel contesto delle neoplasie ematologiche, ma è ancora oggetto di studio per la cura della leucemia linfatica cronica. A dicembre 2023 a San Diego, in California, in occasione dell’ASH2023, la ricercatrice ha presentato, insieme ai suoi colleghi, i risultati aggiornati del trial clinico.
Tra ottobre 2018 e maggio 2020 sono stati arruolati 75 pazienti con leucemia linfatica cronica con una età mediana di 54 anni, caratterizzati per la maggior parte, dalla presenza del gene IGHV non mutato e dall’aberrazione di TP53. Si tratta quindi di pazienti giovani – questa malattia in genere si presenta a 72 anni – e con un assetto biologico sfavorevole che si associa più frequentemente alla comparsa di recidive riducendo le probabilità di sopravvivenza. Il protocollo terapeutico ha previsto la somministrazione di venetoclax per sei settimane, seguito dalla combinazione con il rituximab per sei mesi, a cui sono stati aggiunti altri sei mesi con il solo venetoclax.
La risposta al trattamento è stata positiva e stabile nel tempo, e non si sono verificati effetti collaterali disattesi. Dopo quasi tre anni dalla fine del trattamento, in un paziente su due il livello delle cellule tumorali nel sangue è stato così basso da non essere rilevato dai sistemi diagnostici.
Inoltre alla fine dei tre anni, il 96% dei pazienti è vivente. Le rare eccezioni sono state associate alla contrazione dell’infezione COVID-19, mentre in un solo caso si è avuta l’insorgenza della sindrome da lisi tumorale, ovvero l’insieme di complicazioni metaboliche che possono incorrere in seguito a un trattamento antineoplastico.
Come specifica Francesca Romana Mauro, anche se lo studio ha incluso un numero non elevato di pazienti e non è randomizzato, per cui non confronta in modo diretto differenti approcci terapeutici, “è riuscito a dimostrare che il trattamento funziona”. Tuttavia, da qualche tempo l’attenzione della comunità scientifica è rivolta a un nuovo anticorpo monoclonale, l’obinotuzumab. “Tale anticorpo ha un effetto maggiore del rituximab, ma allo stesso tempo può provocare importanti reazioni avverse, difficili da tollerare soprattutto dalle persone più anziane.”
In alternativa quindi il rituximab, in combinazione con il venetoclax, potrebbe rappresentare un approccio terapeutico meglio tollerato dai pazienti. Poiché si tratta di un farmaco in uso da molti anni e di cui sono disponibili i biosimilari, potrebbe essere anche più sostenibile a livello economico.
Prima di essere introdotto nella pratica clinica della leucemia linfatica cronica, il rituximab dovrà comunque ancora superare tutti i rigidi passaggi di approvazioni da parte degli enti regolatori.
Proprio per rimanere sullo studio di una nuova terapia per i pazienti giovani con uno sfavorevole assetto genetico, il gruppo di ricerca ha deciso di mettere da parte temporaneamente il rituximab e impegnarsi in un nuovo trial clinico volto a testare l’obinotuzumab. “In pazienti con le stesse caratteristiche del trial VERITAS, monitoreremo la risposta molecolare a questo nuovo farmaco. L’idea è di somministrare anche il zanubrutinib, un inibitore della tirosina chinasi di Bruton, soltanto a coloro che non hanno ottenuto una risposta profonda molecolare alla terapia”, conclude Mauro.