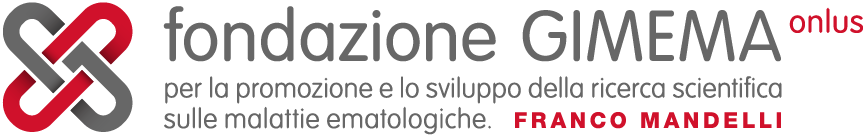Uno studio italiano analizza la salute di quasi mille bambini adottati dall’estero, con un focus su anemia, carenze nutrizionali e contesto pre-adozione.
L’adozione internazionale rappresenta una parte importante del fenomeno migratorio che coinvolge minori provenienti da contesti socio-economici spesso disagiati. Quando i bambini e le bambine giungono in Italia, portano con sé non solo il loro bagaglio culturale, ma anche un profilo sanitario che riflette le condizioni di vita precedenti. Tra i problemi medici più frequentemente riscontrati vi è l’anemia, una condizione nella quale i livelli di emoglobina (o di globuli rossi) sono al di sotto di quelli fisiologici. L’anemia è un problema diffuso, ma che può avere un impatto particolarmente significativo in età pediatrica, perché a lungo termine rischia di danneggiare lo sviluppo cognitivo e fisico.
Un recente studio, pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics, presenta un’analisi dei dati raccolti nel corso di 16 anni nell’ambulatorio di Etnopediatria della Clinica Pediatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, così da tracciare un quadro della diffusione dell’anemia e dei fattori associati a questa condizione tra bambini e bambine arrivate nel nostro Paese per adozione internazionale. Tale studio fornisce dati essenziali per poter sviluppare protocolli sanitari mirati, supportare le famiglie adottive con informazioni concrete e contribuire a un sistema di accoglienza che tuteli pienamente la salute e lo sviluppo dei bambini e delle bambine adottate.
I fattori di rischio dell’anemia nei bambini adottati
Il contesto di origine di bambini e bambine arrivate con l’adozione internazionale può essere molto diverso da quello italiano sotto diversi aspetti (sociali, economici, geografici); spesso, scrivono autori e autrici dello studio, caratterizzato anche dalla malnutrizione e dall’esposizione a malattie infettive. Fattori che possono contribuire, insieme alla predisposizione genetica, anche all’anemia.
“Abbiamo raccolto i dati relativi a 969 pazienti, la cui età media era di cinque anni, in un periodo che andava dal 2007 al 2023, creando quindi un database piuttosto ampio”, spiega Ilaria Lazzareschi, pediatra ed ematologa al policlinico Gemelli e coautrice dello studio. “Oltre ai livelli di emoglobina, abbiamo misurato vari altri parametri bioumorali tra cui, per esempio, ormoni tiroidei, bilirubina, creatinina, nonché naturalmente il valore corpuscolare medio, cioè la dimensione dei globuli rossi”. Infatti, alcuni tipi di anemia possono essere associati alla presenza di globuli rossi più piccoli del normale (anemie microcitiche) oppure più grandi (anemie macrocitiche).
In questa coorte, l’incidenza di anemia è risultata del 13% e, del 5,7% quella associata a microcitosi. Sono inoltre stati individuati i principali fattori di rischio. In particolare, il gruppo di lavoro ha osservato come i livelli più bassi di emoglobina si presentassero nelle fasce d’età più alte (un effetto che ipotizza essere dovuto a un’esposizione prolungata alla malnutrizione e alle infezioni nei Paesi d’origine) e nei bambini e bambine provenienti dalle diverse regioni africane e dall’India.
Quasi il 27% dei bambini, inoltre, presentava bassi livelli di ferritina, indicativi di un’anemia sideropenica, cioè da carenza di ferro assunto con l’alimentazione. Molto frequente, infine, era la carenza di vitamina D, che riguardava il 78% di bambini e bambine e che in alcuni sotto-gruppi era associato anche a livelli più bassi di emoglobina.
Le adozioni internazionali: spunti per genitori e pediatri
La conclusione dello studio è che, in linea di massima, l’anemia si conferma un problema comune nei minori adottati a livello internazionale ed è principalmente legata alle carenze nutrizionali, nonché alle infezioni. Anche le condizioni ambientali precedenti all’adozione possono avere un ruolo, perché autori e autrici hanno osservato come le condizioni peggiori si riscontrino nei pazienti che erano ospitati in case-famiglia o istituti, rispetto a quelli vissuti all’interno di famiglie affidatarie. “Sotto questo aspetto, però vale la pena precisare che il problema potrebbe non essere legato esclusivamente alla dieta.
Anche la componente emotiva potrebbe avere un ruolo, perché la letteratura scientifica mostra come la carenza affettiva possa contribuire indirettamente a una salute più fragile, favorendo carenze nutrizionali o alterazioni dello sviluppo”, spiega Lazzareschi.
C’è un ultimo aspetto dell’analisi che merita di essere sottolineato. “Inizialmente, uno degli obiettivi di questo studio era capire se bambini e bambine arrivati in Italia riflettessero, dal punto di vista epidemiologico, i problemi sanitari dei diversi Paesi di origine. Al contrario di quanto ipotizzato, abbiamo registrato poche patologie e una prevalenza di anemia minore di quanto ci saremmo aspettati”, continua infatti l’ematologa. “Questo potrebbe dipendere da una selezione di partenza: da una parte, i bambini in condizioni di salute peggiore potrebbero non essere proposti per l’adozione; dall’altra, i potenziali genitori adottanti potrebbero rinunciare ad accogliere i bambini con condizioni più gravi. È un dato che sarà importante approfondire, perché potrebbe evidenziare la necessità di un’informazione più accurata alle coppie adottive (che di norma ricevono il fascicolo sanitario del bambino o della bambina in anticipo): far conoscere loro le possibilità terapeutiche e i centri specializzati per alcune patologie disponibili in Italia potrebbe aiutare le adozioni attraverso la consapevolezza dei servizi offerti dal nostro sistema sanitario”.
Lo studio pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics è disponibile a questo link: https://doi.org/10.1186/s13052-025-01944-6