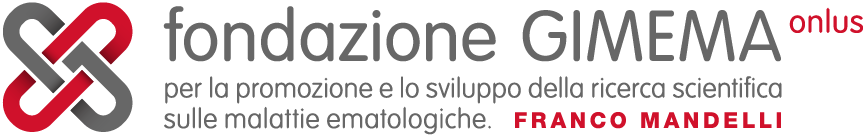Due pazienti con leucoencefalopatia progressiva multifocale dopo trapianto di cellule staminali emopoietiche mostrano un decorso opposto: uno studio evidenzia il ruolo cruciale del sistema immunitario in questa rara patologia
Uno stesso virus, perfino in contesti clinici simili, può dare esiti molto differenti. Ed è con questa considerazione di fondo che è stato pubblicato, sull’Annals of Haematology, un articolo nel quale si riportano due casi clinici: due persone che, dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche, hanno sviluppato leucoencefalopatia progressiva multifocale (PML dall’acronimo ingelse Progressive Multifocal Leukoencephalopathy), una rara patologia del sistema nervoso centrale di origine virale.
È un quadro da cui emerge come il decorso e l’andamento della malattia possono essere influenzati dallo stato del sistema immunitario del paziente, al momento dell’infezione.
Ne abbiamo parlato con le prime autrici dello studio, Biancamaria Mandelli e Roberta Mazzarella, Ematologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione, Policlinico Umberto I – Università Sapienza, Roma.
Cos’è la PML, Leucoencefalopatia progressiva multifocale
La leucoencefalopatia progressiva multifocale non è solo rara: è una condizione neurologica grave e spesso fatale. È causata dalla riattivazione del virus JC (John Cunningham – un tipo di Polyomavirus umano), che infetta la maggior parte della popolazione in forma latente e asintomatica.
La presentazione clinica della malattia è variabile e dipende dalla sede e dall’estensione delle lesioni della sostanza bianca, e consiste, frequentemente, in problemi di coordinazione, debolezza, disturbi visivi, difficoltà di linguaggio e alterazioni della funzione cognitiva.
“Si presenta in condizioni di sistema immunitario compromesso: storicamente, infatti, è stata associata a persone con infezione da HIV. Oggi, invece, può presentarsi nei pazienti ematologici sottoposti a trapianto”, spiegano Mandelli e Mazzarella.
Non esiste ancora una terapia specifica e la diagnosi, cui comunque non sempre si arriva, è spesso tardiva. Conoscerla (e riconoscerla) è dunque particolarmente importante nei contesti clinici ad alto rischio, come quelli dei trapianti di cellule staminali ematopoietiche.
Esiti divergenti
I due casi di studio riportati riguardano due pazienti che, per patologie differenti, avevano dovuto ricevere il trapianto: autologo per il primo paziente, per la recidiva di un linfoma diffuso a grandi cellule B; allogenico, da donatore HLA-identico, per la seconda, a causa di una leucemia mieloide acuta.
“Il primo paziente ha iniziato a presentare sintomi neurologici a cinque mesi dal trapianto. La risonanza magnetica cerebrale ha evidenziato presenza di lesioni; è stata eseguita una puntura lombare, che è risultata negativa”, spiegano le dottoresse. “Le sue condizioni erano però sufficientemente buone da poter eseguire anche una biopsia cerebrale: abbiamo così riscontrato la positività degli anticorpi contro il virus JC”. Il team di cura ha quindi iniziato una terapia con alte dosi di cortisone, che ha portato a un netto miglioramento clinico e radiologico.
La seconda paziente aveva invece sviluppato malattia del trapianto verso l’ospite, complicanza relativamente comune nei sottoposti a trapianto allogenico, ed era quindi stata sottoposta a terapia immunosoppressiva. In seguito, quando sono comparsi i sintomi neurologici, la positività al virus è emersa già dall’esame del liquido cerebrospinale. In questo caso, si è tentato un trattamento con farmaci antivirali. Nel frattempo, i linfociti del donatore sono stati inviati in un laboratorio per ingegnerizzarli e dirigerli contro il virus. “L’intento era provare questa recente strategia terapeutica. Purtroppo, la paziente è deceduta prima che fosse possibile attuare il trattamento”, spiegano ancora le dottoresse.
Il ruolo chiave dell’equilibrio del sistema immunitario
Si delinea quindi un quadro nel quale il decorso della patologia è strettamente legato allo stato immunitario del paziente. Nel primo caso, l’immunità relativamente preservata ha portato a una forma infiammatoria e trattabile con steroidi, mentre nel secondo, la grave linfopenia ha comportato una forma progressiva e fatale della patologia. “È una questione di equilibrio, comunque: anche una risposta immunitaria troppo reattiva avrebbe potuto creare un danno massiccio”, commentano Mandelli e Mazzarella.
E concludono: “Questi dati evidenziano una volta di più come dobbiamo essere in grado di analizzare i singoli casi e stabilire terapie personalizzate, tanto più in presenza di patologie rare e prive di linee guida”.
L’articolo scientifico di Mandelli B, et al., The role of the immune system in progressive multifocal leukoencephalopathy: a comparative analysis of two cases following autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, pubblicato su Annals of Hematology è disponibile al seguente link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00277-025-06258-5