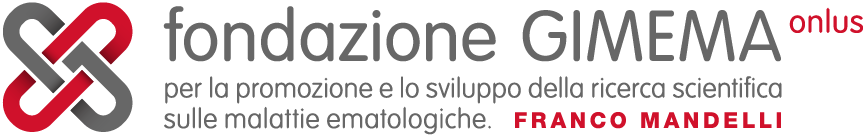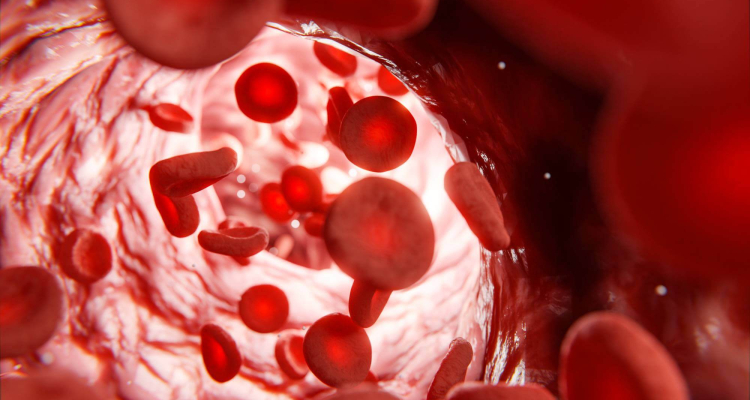La terapia genica apre nuove prospettive per l’anemia falciforme, ma può non essere la scelta idonea per tutti i pazienti. Un consensus paper europeo chiarisce i criteri di accesso: non conta solo la gravità della malattia, ma soprattutto lo stato di salute generale
I tempi stanno cambiando, cantava Bob Dylan nel 1964. Oltre sessant’anni dopo, è con questa stessa considerazione che si apre un editoriale dedicato a presentare i punti principali del consensus paper per l’identificazione delle persone con anemia falciforme idonee alla terapia genica. Perché quest’ultima sta senz’altro cambiando i tempi, almeno per quanto riguarda le prospettive terapeutiche, aprendo alla possibilità di curare malattie che prima non l’avevano: dalla talassemia all’emofilia, ma anche patologie che non coinvolgono il sangue (si pensi all’atrofia muscolare spinale). Un successo cui si affiancano, però, importanti considerazioni su criteri di accesso e sostenibilità della terapia.
Questi due aspetti emergono con chiarezza dal recente consensus paper della European Hematology Association (EHA) e della European Bone Marrow Transplantation (EBMT). «La terapia genica per l’anemia falciforme è stata approvata solo di recente. Nell’Unione Europea, nello specifico, la strategia approvata è quella basata sul gene editing, che modifica direttamente il DNA del paziente per correggere il difetto genetico. Negli Stati Uniti è invece approvata anche la strategia basata sulla gene insertion, l’introduzione di una copia corretta del gene mutato», spiega Emanuele Angelucci, ematologo presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, che ha co-firmato il recente consensus paper e l’editoriale correlato.
L’importanza dello stato di salute, più che della gravità dell’anemia
Ricapitoliamo brevemente come funziona la terapia genica dell’anemia falciforme: in entrambe le strategie, la procedura prevede di prelevare le cellule del paziente, modificarle geneticamente (con l’inserimento di un vettore virale che introduce il gene corretto, nel caso della gene insertion) e poi reinfonderle nell’organismo. Ma, se sono ancora presenti le cellule ematopoietiche con la mutazione responsabile della formazione di emoglobina anomala, le cellule modificate non possono attecchire e proliferare. Ecco perché la terapia genica richiede necessariamente di essere preceduta dalla mieloablazione, un trattamento per distruggere le cellule del midollo osseo del paziente che di solito si esegue con la chemioterapia.
«Oggi la terapia convenzionale per l’anemia falciforme si basa su farmaci che stimolano la produzione di emoglobina fetale e sul trapianto di midollo, che risulta curativo. Ci sono dei limiti, in particolare la necessità di seguire la terapia farmacologica per tutta la vita e le difficoltà a trovare un donatore HLA (Human Leukocyte Antigen) identico per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche. «La mieloablazione necessaria per la terapia genica, d’altro canto, comporta vari rischi e non tutti i pazienti sono in condizioni cliniche tali da tollerarla. È per questa ragione che uno degli aspetti più importanti a emergere dal consensus paper è la necessità di applicare la terapia solo in persone in buone condizioni di salute generale. È questa, prima ancora della gravità della malattia, a rappresentare il principale criterio di accesso alla terapia genica».
Equità di salute significa considerare anche la sostenibilità economica
Un altro aspetto evidenziato dal documento EHA/EMBT riguarda l’età dei pazienti. I trial pediatrici per la terapia genica, infatti, sono in corso; quelli conclusi per gli adulti hanno coinvolto solo persone fino a 35 anni. «Mancano i dati per fasce d’età superiori: abbiamo quindi raccomandato che, per pazienti oltre i 35 anni, si proceda in modo graduale, su base strettamente controllata», continua Angelucci. «Così come sarà necessario il follow up a lungo termine, perché queste sono terapie recenti per le quali dobbiamo monitorare eventuali eventi avversi ritardati».
Infine, non si può trascurare la sostenibilità economica. Se è vero che la salute dovrebbe essere un diritto di ogni persona, i costi molto elevati della terapia genica pongono nei fatti un limite concreto al suo accesso, per il quale il divario rimane infatti molto marcato tra i Paesi ad alto e quelli a basso reddito. «Nella nostra penisola, la contrattazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è in corso, ma è innegabile che la sostenibilità e l’equità di queste cure rimangano una sfida aperta in molte aree del mondo, tra cui per esempio l’Africa sub-sahariana, in cui l’anemia falciforme è endemica», conclude Angelucci.
L’editoriale di De Franceschi L, Angelucci E, “Learn and Know” in the era of gene addition/gene editing based approaches for sickle cell disease: The EHA-EBMT consensus paper, pubblicato su Bone Marrow Transplantation è disponibile a questo link:
https://doi.org/10.1038/s41409-025-02561-x