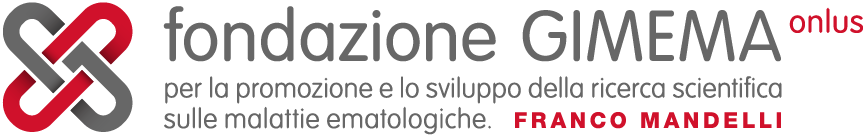Un nuovo studio del network Campus ALL mostra che la pegasparaginasi (PEG-ASP) può essere utilizzata anche negli adulti con leucemia linfoblastica acuta di età superiore ai 55 anni, se dosata con attenzione. L’analisi su 90 pazienti trattati real-life, secondo lo schema LAL1913, conferma la fattibilità e l’efficacia del farmaco, pur evidenziando la necessità di monitorare la tossicità epatica.
I protocolli pediatric-inspired, modellati su quelli usati per l’età pediatrica, hanno migliorato in modo sostanziale il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (LAL, dall’acronimo inglese acute lymphoblastic leukemia) negli adulti. Ma per i pazienti più anziani ci sono ancora dei limiti legati agli effetti collaterali di questi regimi intensivi. Tra i farmaci che pongono questo problema ve n’è uno che, nei giovani e nei bambini, è apparso di estrema importanza nel trattamento: l’asparaginasi. Nel 2013, il trial GIMEMA LAL1913, aveva introdotto l’asparaginasi nella forma di pegasparaginasi (PEG-ASP) anche per gli adulti fino a 65 anni, con una dose ridotta per i pazienti di età superiore ai 55 anni. Il protocollo ha mostrato la fattibilità anche in questi pazienti.
In questo contesto mancava comunque ancora un tassello: i dati specifici degli esiti, in termini per esempio di fattibilità e tollerabilità del trattamento, nel contesto real-life. Uno studio, da poco pubblicato su Annals of Haematology, firmato da un gruppo di ematologi ed ematologhe italiani, ha approfondito proprio questo aspetto.
Uno studio real-life per valutare la fattibilità del trattamento
“Questo lavoro rappresenta una sotto-analisi dello studio pubblicato all’inizio dell’anno, su pazienti trattati in real-life secondo lo schema LAL1913: infatti, le evidenze sul trattamento delle persone con più di 55 anni sono ancora limitate, anche a causa della scarsa rappresentazione nella popolazione di pazienti”, spiega Davide Lazzarotto, primo autore dello studio ed ematologo presso il Centro Trapianti e Terapie Cellulari dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. “Abbiamo voluto quindi indagare più nel dettaglio gli esiti clinici (tassi di remissione completa, malattia minima residua, sopravvivenza) e altri aspetti della terapia con PEG-ASP”.
Il gruppo di ricerca ha seguito 90 pazienti trattati in real-life secondo lo schema LAL1913, concentrandosi sui primi due cicli di chemioterapia che includevano la PEG-ASP. Quasi tutti (96%) i pazienti hanno ricevuto almeno una dose di PEG-ASP durante i primi due cicli di trattamento; oltre la metà (circa il 59%) l’ha ricevuta in entrambi i cicli. Un terzo circa dei pazienti, per età avanzata o per comorbidità epatiche e dunque a maggior rischio di effetti collaterali, ha ricevuto una dose ridotta di PEG-ASP. In alcuni casi, infine, il farmaco non è stato somministrato nel secondo ciclo: nella maggior parte di questi casi, la sospensione è stata decisa perché nel primo ciclo si erano già manifestati problemi epatici legati al trattamento.
Buoni risultati di remissione, ma con le dovute cautele nel trattamento
“I dati che abbiamo raccolto hanno confermato quella che prima era solo un’impressione clinica: essenzialmente, anche se è vero che si riscontrano delle tossicità, i pazienti possono portare avanti il loro programma terapeutico, eventualmente con adeguate modulazioni, e peraltro con ottimi risultati”, spiega Lazzarotto.
Tra gli eventi avversi cui si riferisce l’ematologo, il principale è l’epatotossicità, che ha rappresentato la principale causa di sospensione del farmaco; tuttavia, probabilmente grazie agli aggiustamenti preventivi di dose, il gruppo di ricerca non ha riscontrato una correlazione significativa tra tossicità ed età, obesità o malattia epatica preesistente. Inoltre, dopo i primi cicli di terapia, quasi tutti i pazienti (94%) hanno raggiunto la remissione completa della malattia, e il risultato è rimasto stabile anche dopo il terzo ciclo (93%). Ancora più importante, dopo il primo ciclo, il 40% dei pazienti non mostrava più malattia minima residua (assenza di tracce di cellule leucemiche che rappresenta uno dei più forti determinanti per la sopravvivenza). Dopo il terzo ciclo, la percentuale di pazienti con malattia residua minima negativa aumentava al 68%.
“I dati confermano che, pur non essendo l’unico attore, la PEG-ASP ha un ruolo importante anche nel trattamento dei pazienti con più di 55 anni, sebbene vada somministrata con le dovute cautele: per questo raccomandiamo una valutazione pre-trattamento accurata e l’uso di linee guida di riduzione di dose per pazienti anziani o con comorbidità epatiche”, conclude Lazzarotto.
“In prospettiva, inoltre, anche se servirebbero molti altri studi per pensare di poter eliminare la PEG-ASP dal trattamento, l’associazione con immunoterapie di prima linea potrebbe migliorare la tollerabilità riducendo l’intensità chemioterapica”.
L’articolo originale di Lazzarotto D, et al., Pegaspargase administration and tolerability in patients aged 55 years or older with acute lymphoblastic leukemia treated with the LAL1913 program. A subanalysis of the Campus ALL group, pubblicato su Annals of Hematology è disponibile al seguente link
https://link.springer.com/article/10.1007/s00277-025-06550-4