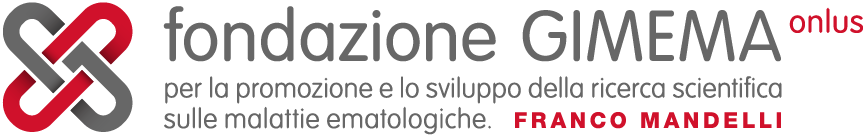Un ampio studio italiano ha confrontato imatinib con i farmaci più recenti di seconda generazione nel trattamento della leucemia mieloide cronica. Con i nuovi farmaci le risposte sono più rapide, ma la prognosi dipende soprattutto dal profilo di rischio al momento della diagnosi
Negli ultimi vent’anni, la comprensione più approfondita dei meccanismi molecolari e il miglioramento delle opzioni terapeutiche disponibili, hanno trasformato la leucemia mieloide cronica (CML, Chronic myeloid leukemia) da patologia con poche possibilità di trattamento, a cronica e gestibile a lungo termine. La maggior parte dei dati oggi disponibili deriva però da studi clinici, che spesso non riflettono appieno la complessità osservata nella pratica quotidiana, nei cosiddetti dati real-world. Uno studio italiano, pubblicato su Cancer, ha analizzato i dati rilevati in una coorte prospettica e reale di pazienti con CML, considerando sia i fattori di rischio basali al momento della diagnosi, che il tipo di trattamento ricevuto.
L’obiettivo era capire se, nella pratica clinica quotidiana, i farmaci più recenti offrano davvero un vantaggio in termini di sopravvivenza e riduzione della progressione della malattia.
La prognosi della leucemia mieloide cronica è cambiata radicalmente grazie all’introduzione degli inibitori della tirosin-chinasi (TKI, Tyrosine Kinase Inhibitors). Imatinib è stato il capostipite di questa classe di farmaci, seguito da molecole di seconda generazione capaci di ottenere risposte molecolari più rapide e profonde, anche se con più effetti avversi. Tuttavia, resta la domanda: questi risultati, osservati spesso in studi clinici controllati, si confermano anche nella pratica reale?
Nello studio, promosso dal network italiano CML Campus, sono stati raccolti i dati di 1433 pazienti con nuova diagnosi di leucemia mieloide cronica in fase cronica, arruolati in 68 centri ematologici di 19 regioni. Quasi la metà dei pazienti era stata trattata con imatinib, mentre l’altra metà aveva ricevuto un inibitore di seconda generazione. Oltre alla risposta ai farmaci, i ricercatori hanno analizzato anche il ruolo del punteggio ELTS (EUTOS long-term survival), uno strumento che permette di stimare il rischio di progressione e di morte legata alla malattia in base a fattori clinici e biologici rilevati al momento della diagnosi.
I risultati ottenuti dai dati real world hanno confermato che i TKI di seconda generazione portano a una risposta molecolare più veloce: già nei primi sei mesi la maggior parte dei pazienti trattati con nilotinib, dasatinib o bosutinib raggiungeva livelli di malattia residua molto bassi, un risultato che si manteneva anche nel tempo e che si osservava soprattutto per il sesso femminile e in presenza di un basso rischio ELTS.
Tuttavia, questo vantaggio iniziale non si è tradotto in differenze sostanziali nel numero di progressioni della leucemia mieloide cronica, né nella sopravvivenza globale rispetto a chi aveva iniziato con il TKI di prima generazione imatinib. La sopravvivenza globale a cinque anni era infatti molto alta per tutti i pazienti, pari all’88%.
A fare la differenza sembrerebbe essere soprattutto il rischio iniziale: i rischi intermedi e alto erano associati a più progressioni della malattie e più decessi.
Inoltre, la maggior parte degli eventi avversi si verificava nei primi due anni dalla diagnosi, sottolineando l’importanza di un monitoraggio ravvicinato in questa fase.
In conclusione, per i ricercatori la scelta della terapia deve essere personalizzata e bilanciare i vantaggi dei nuovi farmaci con le caratteristiche individuali del paziente, come età, comorbilità e rischio iniziale.
L’articolo originale di Giai V, et al., Chronic myeloid leukemia outcomes according to baseline risk and first-line treatment in real-world settings: Data from the Italian Network/CML Campus, pubblicato su Cancer è disponibile al seguente link https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.35963