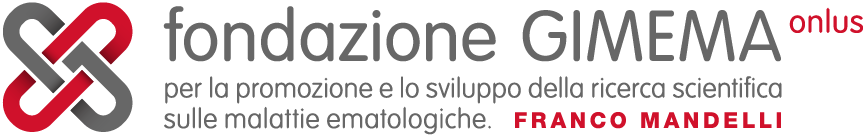Uno nuovo strumento prognostico, che mette insieme sia indicatori relativi al paziente con linfoma che alla malattia virale COVID-19, riesce a identificare i pazienti più fragili che hanno bisogno di interventi prioritari e di prevenzione. Lo ha messo a punto un gruppo di ricercatori che fa parte dell’l’ITAHEMA-COV (Italian Hematology Alliance on COVID-19), che mette insieme le più importanti società scientifiche in ambito ematologico, trapiantologico e infettivologico italiano.
“Questo studio ci permette di avere un documento che identifica su quali pazienti concentrare la spesa pubblica, prevenendo, così, danni gravi o morte”, ha commentato Carlo Visco, professore associato presso il Dipartimento di Medicina dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, riguardo allo score prognostico identificato nello studio di cui è a capo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Blood Advances. Visco ha descritto, in una intervista a GIMEMA Informazione, la semplicità e l’efficacia di questo score, uno strumento che potrebbe salvare molte vite.
Qual era l’obiettivo principale dello studio?
“Grazie ai dati raccolti abbiamo realizzato uno score prognostico, ovvero un sistema per valutare i principali fattori di rischio verso malattia grave o decesso prematuro nei pazienti con linfoma. Lo score si basa su età, sesso, conteggio dei linfociti e delle piastrine ed è molto semplice da usare.
L’utilità dello score risiede soprattutto nel fatto che riesce a identificare le popolazioni più fragili, delineando i soggetti prioritari per interventi di prevenzione. Questi individui avranno bisogno, in maniera prioritaria, della terza o della quarta dose, o, se più a rischio di morte, avranno bisogno delle terapie più efficaci per combattere l’infezione, come l’uso degli anticorpi monoclonali per il COVID o degli antivirali precoci, come ad esempio, il paxlovid o il remdesivir che, che vengono utilizzati entro 5 giorni dalla diagnosi.
Un riconoscimento tempestivo della malattia è fondamentale per aumentare le probabilità di guarigione. Lo score è semplice da usare: bastano le prime analisi ambulatoriali per poter già capire il rischio che corre un paziente”.
Com’è nato questo progetto?
“Il gruppo dal quale è partito il lavoro è l’ITAHEMA-COV (Italian Hematology Alliance on COVID-19) che racchiude le più importanti società scientifiche in ambito ematologico, trapiantologico e infettivologico italiano. Stiamo parlando di più di 80 centri che hanno contribuito alla raccolta dati di pazienti con malattie ematologiche e infezione da COVID-19. Per quanto riguarda il nostro studio, ci siamo focalizzati sui casi di linfoma in cui è stata riscontrata un’infezione da COVID-19. È importante sottolineare che i dati di cui parliamo sono stati raccolti tra il 2020 e il 2021, durante la prima e seconda ondata della pandemia, quindi prima dell’avvento dei vaccini e delle nuove varianti. Lo studio, in particolare, presenta due elementi di novità nel panorama delle ricerche in questo campo: vi è una coorte raccolta prospetticamente e, quindi, su cui si focalizza un’analisi trasversale di diversi parametri del gruppo oggetto di studio. Inoltre, vi è il vantaggio di aver pazienti ospedalizzati e non. In tal modo abbiamo una rappresentazione più realistica della popolazione, aggiungendo un ulteriore elemento ad oggi ancora non studiato, ovvero l’andamento dell’infezione in pazienti gestiti a domicilio”.
Nel vostro lavoro raccontate che il trattamento anti-CD20 non ha avuto un impatto sulla sopravvivenza dei pazienti, come se lo spiega?
“Questo è un argomento molto dibattuto. In questo trattamento viene utilizzato l’anticorpo monoclonale rituximab, o un suo analogo, che si attacca a una proteina specifica (la CD20) presente solo sui linfociti B del paziente, fra le cellule del sistema immunitarie più colpite dal linfoma. Facendo così le rende più visibili al sistema immunitario che quindi le attacca, diminuendone il numero sia di sane sia di malate, con un conseguente abbassamento delle difese immunitarie. Generalmente, all’interno di una popolazione con linfoma, chi viene trattato con rituximab e/o chemioterapia è svantaggiato rispetto a chi non ha mai ricevuto terapie antitumorali, per via dell’immunodeficienza indotta dal trattamento. All’epoca non potevamo saperlo perché non vi erano abbastanza studi a riguarda, ma oggi è chiaro: aver fatto una terapia con anticorpi anti-CD20 nei 6 o 12 mesi precedenti alla vaccinazione riduce significativamente la risposta anticorpale del vaccino. Guardando poi a tutti i pazienti trattati nello studio – oltre 500 – aver fatto o no il trattamento anti-CD20 non modifica l’aspettativa di vita dei pazienti. È possibile fare un discorso simile con bendamustina, agente chimico impiegato anch’esso nel trattamento del linfoma. Riassumendo: nel caso fosse necessario il trattamento anti-CD20, questo dovrebbe essere reso disponibile senza timore insieme alla terapia migliore esistente per il paziente”.
Nel lavoro parlate anche di una più alta sopravvivenza per chi ha un linfoma Hodgkin, sa il motivo di questo risultato?
“L’età fa la differenza. Stiamo parlando di persone molto giovani, di 20 o 30 anni, generalmente non ospedalizzate e che fanno terapie meno immunosoppressive. Tutto questo è già di per sé un vantaggio e contribuisce all’aumento del tasso di sopravvivenza dei pazienti. In particolar modo l’età gioca un ruolo importante. Osservando lo score prognostico che abbiamo realizzato è possibile notare proprio come l’età sia il fattore più importante per predire la severità della malattia. Tengo a specificare nuovamente che questi dati sono di un’epoca pre-vaccinale e non si applicano per forza alle popolazioni odierne. Ciò non sminuisce, però, il valore dello score stesso, che, in ogni caso, aiuta a valutare tempestivamente i pazienti ad alto rischio”.
Può spiegare meglio l’influenza dei fattori che avete delineato nello score prognostico?
“Oltre all’età, il sesso ha una buona percentuale di influenza, con i maschi che sono più a rischio. Per quanto riguarda il conteggio di piastrine e linfociti il discorso è simile: se sei severamente immunodepresso, ad esempio, le probabilità di aver malattia grave o di morte sono più alta. Inoltre, c’è da considerare che un conteggio basso di piastrine si associa ad infiammazione nel corpo, le così dette microangiopatie, che possono causare piastrinopenie, quindi carenza di piastrine nel sangue. Quando questa mancanza diventa severa è segnale che la malattia COVID è attiva. Possiamo dire, quindi, che lo score mette insieme sia fattori dell’ospite che della malattia virale”.
Avete scoperto che l’intervallo di tempo tra la diagnosi di linfoma e l’infezione da COVID-19 è inversamente correlato alla mortalità. Come mai?
“Ci siamo chiesti: quale rischio corrono i pazienti che hanno avuto un linfoma, hanno fatto una terapia e sono poi guariti, ad esempio, 5 o 6 anni fa?
Analizzando i dati abbiamo visto che il rischio di mortalità si riduceva significativamente dopo tre anni dalla diagnosi.
Questo significa che se hai avuto una diagnosi e sei guarito da oltre 3 anni, le probabilità di morte crollano drasticamente e si avvicinano quasi a quelle della popolazione generale. Quindi, i 3 anni rappresentano una soglia decisionale importante per consigliare la vaccinazione a tutti coloro che hanno fatto una terapia entro questo tempo limite”.
Quali potrebbero essere i prossimi passi per questa ricerca?
“Stiamo tentando di validare questo score in altre casistiche come istologie singole e leucemia linfatica cronica, dove molti gruppi europei stanno tentando di condurre ricerche approfondite. Vorremmo anche vedere l’impatto delle vaccinazioni sulla mortalità dei pazienti fragili con linfoma che, prima del vaccino, era altissima, circa il 30% a 30 giorni. Questo vuol dire che tre pazienti su dieci morivano dopo 30 giorni dall’infezione. Un altro argomento interessante è capire il rapporto fra morbilità e vaccinazioni, indagando se i pazienti dopo i vaccini vengono ospedalizzati meno e se hanno sintomi minori. Bisogna anche capire l’impatto dell’utilizzo degli antivirali precoci sui pazienti, visto che in letteratura c’è poco. Infine, sarebbe interessante analizzare l’efficacia del vaccino sull’immunità cellulare. Questo perché, nonostante ci siano studi che mostrano che gli anticorpi anti-CD20 abbattono l’immunità umorale, ovvero quella mediata da anticorpi, alcuni dati preliminari mostrano che il vaccino dà comunque un vantaggio per l’immunità cellulare. Questa è un tipo di risposta immunitaria scatenata dal riconoscimento antigenico da parte dei linfociti T e che coinvolge le cellule della memoria, particolari cellule che, una volta entrate in contatto con un antigene, possono riconoscerlo anche a distanza di anni dalla prima infezione”.