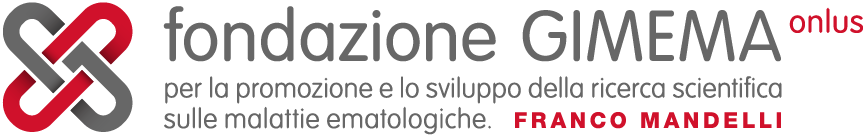Un questionario rivolto ai centri AIEOP rivela ampia variabilità nelle indicazioni dietetiche per i pazienti pediatrici sottoposti a chemioterapia o trapianto e apre interrogativi sull’equilibrio tra protezione dei pazienti e qualità dell’alimentazione.
La sicurezza alimentare è un tema chiave nei pazienti pediatrici immunocompromessi, ma in Italia le indicazioni dietetiche adottate dai centri di onco-ematologia pediatrica sono ancora molto diverse tra loro. Lo segnala uno studio promosso dal gruppo di lavoro sulle malattie infettive dell’AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica) e pubblicato sulla rivista Pediatric Blood & Cancer.
I ricercatori hanno inviato un questionario online rivolto a tutti i centri della rete AIEOP, che in Italia conta 49 strutture, di cui 21 abilitate al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT, dall’acronimo inglese Hematopoietic Stem Cell Transplantation) allogenico o autologo. Lo strumento, inviato nell’aprile 2024, mirava a raccogliere informazioni sulle pratiche alimentari adottate in diverse fasi del trattamento, sia in durante la degenza in ospedale che a domicilio. Una sezione del questionario chiedeva anche di segnalare casi di infezioni alimentari (FBI, dall’acronimo inglese Foodborne illnesses). In caso di risposta affermativa, ai centri veniva richiesto di compilare una scheda clinica dettagliata. Hanno partecipato 22 centri AIEOP; 13 eseguono regolarmente il HSCT allogenici. Il questionario è stato compilato da un medico in tutti i casi.
Una dieta molto diffusa, ma indefinita
Lo studio ha evidenziato che tutti i centri forniscono ai pazienti indicazioni relative alla dieta, e che il 73% dei centri raccomanda la cosiddetta dieta neutropenica (ND, neutropenic diet) o restrittiva durante il ricovero. Nel 77% dei casi la ND è raccomandata anche a domicilio.
Questa dieta esclude una serie di alimenti con l’obiettivo di minimizzare il rischio di infezioni alimentari nei pazienti immunocompromessi a causa della malattia, delle terapie o di un recente HSCT.
Il problema è che non esiste una definizione condivisa della dieta neutropenica. L’efficacia dell’approccio restrittivo è stato messo in discussione in letteratura: a oggi non ci sono prove che questo tipo di dieta, comunque sia declinata, aiuti a evitare le infezioni alimentari in questi pazienti.
Come sottolinea il dottor Davide Leardini, ricercatore in onco-ematologia pediatrica all’Università di Bologna e primo autore dello studio: “La cosiddetta dieta neutropenica è presente da tanti anni, ma non esiste una definizione univoca. La nostra indagine ha evidenziato che alcuni alimenti concessi in un centro per una certa tipologia di paziente possono essere vietati in un altro. Inoltre, un centro che afferma di non applicare la ND, può applicare restrizioni anche più severe. Ogni centro, in pratica, applica una diversa definizione di dieta neutropenica”.
Tutti i centri che hanno risposto raccomandano a tutti i pazienti di evitare
- latte non pastorizzato
- frutta fresca senza buccia
- formaggi con muffe
- prodotti da forno freschi
- uova crude
- carne cruda
- alimenti a base di uovo crudo
- pesce crudo o affumicato
- salumi
- molluschi
- avanzi di cibi cotti in tutte le fasi del trattamento.
Per i pazienti a maggior rischio, frutta e verdura fresche risultano tra gli alimenti più frequentemente esclusi nelle diete neutropeniche, e alcuni centri impongono restrizioni ulteriori: no a sushi, marinature e specifiche creme.
Sono generalmente concessi alimenti come pizza fatta in casa o surgelata, pâté, hummus, frutta candita o sciroppata, gelato industriale e snack confezionati.
I casi di infezione alimentare nei centri sono rari
Sono emersi in tutto 10 casi di infezione alimentare (FBI). Sono stati segnalati da 7 centri e si sono verificati negli ultimi 10 anni circa. Cinque pazienti avevano mangiato alimenti non raccomandati; due sono deceduti per infezioni da Listeria monocytogenes e Bacillus cereus. In quattro casi l’infezione è avvenuta a domicilio e non durante il ricovero.
Per definire le FBI, lo studio ha adottato i criteri del CDC (Centers for Disease Control and Prevention), che includono casi confermati microbiologicamente in presenza di una storia alimentare compatibile nelle 24 ore precedenti, oppure la rilevazione di un patogeno tipico anche senza esposizione alimentare nota.
Questo tipo di studio non può stimare un’incidenza precisa, ma Leardini sottolinea: “Dieci pazienti in dieci anni in ventidue centri sono un numero ridotto”.
Di fronte a un numero così basso di eventi, e considerando che ogni anno si effettuano circa 2000 diagnosi di tumori pediatrici secondo i registri AIEOP, si apre la questione dell’equilibrio tra protezione dei pazienti e qualità della dieta, oltre che della necessità di linee guida nazionali basate sulle evidenze scientifiche.
Il peso delle esclusioni alimentari
Non c’è dubbio che molti degli alimenti universalmente vietati nei centri (per esempio uova crude, carne cruda, latte non pastorizzato…) costituiscano un pericolo per questi pazienti. In un documento di consenso dell’EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) Pediatric Diseases Working Party (PDWP), questi cibi vengono elencati come i principali alimenti a rischio nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto. E, del resto, molti possono essere rischiosi anche per le persone sane.
Il problema può presentarsi laddove si applichino restrizioni ulteriori, come l’esclusione di frutta e verdure fresche che risulta comune nelle diete neutropeniche. Oltre a ridurre la varietà della dieta e interferire sulla qualità di vita, rinunciare a questi alimenti può limitare l’assunzione di fibre micronutrienti fondamentali proprio per questo tipo di pazienti. Spiega Leardini: “Ci sono evidenze che mostrano come l’assunzione di fibre aumenti la risposta all’immunoterapia in altri setting oncologici. Inoltre, numerosi dati associano la composizione del microbiota a esiti clinici, anche nei pazienti non trapiantati, e le restrizioni dietetiche possono inficiare negativamente sul microbiota”.
Dato il basso numero di infezioni registrate e la forte eterogeneità delle raccomandazioni, è quindi possibile ipotizzare che, al momento attuale, spesso si applichino restrizioni troppo severe in un’ottica costi-benefici. Gli autori citano a supporto uno studio sperimentale secondo cui le diete non restrittive non aumentano il rischio di infezione post-trapianto.
“I dati preliminari suggeriscono che un’eccessiva restrizione alimentare possa avere un impatto negativo nei pazienti onco-ematologici in un bilancio rischio-beneficio. È probabile che indicazioni più simili a quelle rivolte alla popolazione generale possano essere applicate anche a questi pazienti. Studi prospettici potranno aiutarci a chiarire queste ipotesi”.
Questo non significa sottovalutare le infezioni alimentari, che sono un problema reale in questo contesto, ma che probabilmente sarebbe più ragionevole evitare un insieme più ristretto di cibi a parità di riduzione del rischio.
Igiene più che divieti
I ricercatori propongono di spostare l’attenzione dalla lista dei cibi vietati all’educazione alla corretta gestione del cibo, come suggerisce anche la EBMT: “Come si conserva, come si cuoce, come si lava… sono indicazioni valide anche per la popolazione generale, ma acquisiscono maggiore importanza nei pazienti onco-ematologici”.
Anche in questo caso delle pratiche condivise a livello nazionale potrebbero aiutare. Per esempio, quasi tutti i centri raccomandano l’uso di disinfettanti per lavare frutta e verdura; la EBMT raccomanda invece di lavare a fondo con acqua corrente.
Nella ricerca gli autori sottolineano la necessità di adottare raccomandazioni nazionali validate in modo uniforme tra i centri clinici, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza nell’applicazione delle pratiche mediche. L’avvio di studi multicentrici prospettici su scala nazionale è inoltre necessario per ottenere la potenza statistica necessaria a valutare l’incidenza della FBI nei diversi gruppi di trattamento. Questo permetterebbe di passare a una gestione più standardizzata, efficace e basata sull’evidenza.
“Vorremmo procedere su questa strada”, conferma Leardini. “Al momento non ci sono delle vere e proprie linee guida nazionali e condivise. Le linee guida potrebbero aiutare nell’omogeneizzare le pratiche e a capire meglio i rischi e i benefici collegati alla dieta”.
L’articolo scientifico originale di Leardini D, et al., Food Safety Practices and Foodborne Illness in Italian Pediatric Oncology and Hematology Centers: A Survey on Behalf of the Infectious Disease Working Group of AIEOP, pubblicato su Pediatric Blood and Cancer è disponibile a questo link: https://doi.org/10.1002/pbc.31782