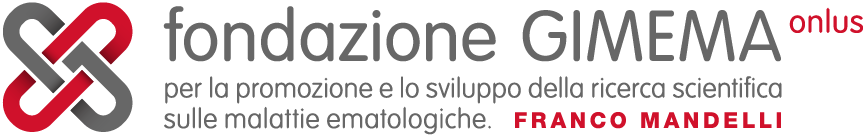I pazienti affetti da leucemia a cellule capellute da anni possono contare su un valido ed efficace chemioterapico: la cladribina. Una recente ricerca rivaluta il farmaco e il primo autore, Livio Pagano, responsabile del reparto di ematologia geriatrica ed emopatie rare del Policlinico Gemelli di Roma, conferma a GIMEMA Informazione: “Nonostante esistano nuove terapie questo tipo di trattamento è ancora in grado di portare dei risultati ottimi: l’80% dei pazienti sono lungo-sopravviventi senza recidive”.
Nonostante la ricerca sulla leucemia a cellule capellute (HCL) stia facendo passi da gigante, soprattutto grazie ai farmaci anti-BRAF come il vemurafenib in combinazione con rituximab che sta portando buoni risultati, non è il caso di “mettere in soffitta” il trattamento con cladribina usato fino ad ora perché, secondo Livio Pagano, “è un trattamento che ancora adesso dà buoni risultati a fronte di una tossicità contenuta”.
Si tratta di uno studio multicentrico retrospettivo che ha coinvolto 18 centri ematologici italiani, i cui risultatati sono stati pubblicati su Blood Cancer Journal.
Si può considerare il più grande e completo studio sul trattamento dei pazienti affetti da leucemia a cellule capellute con cladribina che ha analizzato un grande bacino di pazienti: ben 513 in un arco temporale che va dal 1991 al 2019.
Tutti i partecipanti allo studio sono stati trattati con cladribina con due vie di somministrazione: 330 pazienti, circa il 64,3%, ha ricevuto il farmaco per via endovenosa; mentre 183, il 35,7%, per via sottocutanea. A rendere così speciale questa grande analisi dati, però, è il periodo di osservazione a lungo termine:
dopo 15 anni di follow-up l’80% dei pazienti presentava remissione totale dei sintomi, senza recidiva.
Le caratteristiche biologiche dell’HCL sono state ben chiarite. Dal 2011 una serie di studi hanno approfondito sempre più la causa della HCL e, mediante un estensivo sequenziamento del genoma di pazienti affetti dalla malattia, si è scoperto che la mutazione del gene BRAF (BRAF-V600E) è responsabile del suo sviluppo.
La HCL è una forma di leucemia cronica che determina una marcata riduzione di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine a vantaggio di un tipo di globuli bianchi, linfociti B, che vanno incontro a una iperproduzione, provocando un accumulo nell’organismo. La mutazione del gene BRAF determina la trasformazione neoplastica dei linfociti B maturi che assumono un peculiare aspetto morfologico: delle propaggini citoplasmatiche simili a capelli si dipartono dalla superfice delle cellule, da cui il nome stesso della malattia.
È una malattia rara, con un’incidenza stimata di 1 caso ogni 500.000 persone ed è molto più frequente negli uomini che nelle donne. Se non trattata la HCL può causare nei pazienti infezioni molto gravi.
Per curare la malattia fino a 30 anni fa era utilizzata una terapia con interferone e cortisone unita alla chemioterapia convenzionale. “Non era molto efficace, soprattutto visto che spesso non veniva somministrata in tempo poiché questa è una malattia che può avanzare per un lungo periodo asintomatica”, conferma lo stesso Livio Pagano.
Un altro trattamento che veniva somministrato era con tripsina, un enzima responsabile della digestione delle proteine, in infusione continua per 7 giorni. Secondo l’autore dello studio però “questo trattamento era logorante perché significava che il paziente doveva rimanere ricoverato per una settimana in ospedale e non poteva muoversi”.
In fine, la scoperta e l’utilizzo degli analoghi delle purine, prima la pentostatina poi la cladribina, ha stravolto la storia clinica della patologia. Questi sono due farmaci citotossici che ora si utilizzano per la prima linea. La loro azione è semplice: una volta all’interno dell’organismo vengono convertiti in una sostanza chimica in grado di intervenire nella produzione di nuovo DNA o RNA, impedendo la divisione cellulare (che determina la produzione di cellule) e rallentando la progressione della leucemia.
Unico problema di questo trattamento era che il paziente doveva passare diverso tempo in ospedale, questione che, come mostra questa ricerca, è stata completamente risolta.
“I pazienti possono ricevere la terapia in day hospital e dai nostri risultati si evince, inoltre, che non vi è alcuna differenza fra la somministrazione endovenosa e sottocutanea – aggiunge Livio Pagano. Proprio per questo il trattamento con cladribina risulta essere estremamente comodo. Il paziente può tranquillamente recarsi in ambulatorio e in poco tempo ricevere la cladribina in maniera non invasiva, con un enorme risparmio di tempo e denaro”.