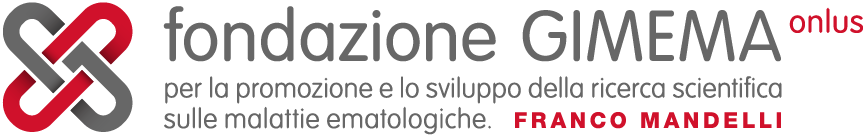La combinazione di inibitori tirosin-chinasici (TKI) e immunoterapia con l’anticorpo bispecifico blinatumomab ha profondamente modificato il trattamento della leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva. Un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Current Issues in Molecular Biology descrive questa importante evoluzione.
Negli ultimi venticinque anni, il trattamento della leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva (Ph+ ALL, nell’acronimo inglese) ha presentato una trasformazione radicale nell’approccio terapeutico e, di conseguenza, nei risultati raggiunti. Se in passato il trapianto allogenico rappresentava l’unica opzione per garantire ai pazienti una sopravvivenza a lungo termine, oggi la combinazione di inibitori tirosin-chinasici (TKI) e immunoterapia con l’anticorpo bispecifico blinatumomab ha profondamente modificato il paradigma terapeutico di questa patologia. In questo contesto, l’uso dei TKI come terapia di mantenimento per evitare il rischio di recidiva dopo il trapianto di cellule staminali emopoietiche assume un ruolo sempre più centrale. A delineare questa evoluzione è Martina Canichella, dirigente medico del gruppo trapianti di ematologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, e autrice di un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Current Issues in Molecular Biology.
“L’attenzione del nostro gruppo di lavoro, il cui responsabile è il professor Paolo de Fabritiis, si è focalizzata proprio sull’utilizzo dei TKI come strategie terapeutiche per evitare la recidiva post-trapianto della Ph+ ALL. Questo è un argomento di grande interesse nella comunità scientifica. Gli ultimi studi GIMEMA, il GIMEMA LAL2116 e a seguire il ALL2820, con un approccio chemio-free in cui il TKI viene associato al blinatumomab, hanno dimostrato che il paziente con leucemia linfoblastica acuta Ph+ può raggiungere percentuali elevate di sopravvivenza senza dover necessariamente ricorrere al trapianto allogenico. In quest’ottica si può comprendere bene come il paziente che verrà sottoposto a trapianto allogenico sarà effettivamente proprio quello ad alto rischio, per il quale sarà di fondamentale importanza mettere in atto delle strategie di mantenimento post-trapianto per evitare l’insorgenza della recidiva”, spiega Canichella.
Lo studio condotto è una revisione della letteratura scientifica e delle linee guida esistenti. “Siamo partiti cercando di dare risposta a tre domande fondamentali: quale TKI scegliere nel mantenimento post-trapianto, in quali condizioni somministrarlo e per quanto tempo? Nel contesto del post-trapianto, è possibile distinguere due scenari in base alla capacità di monitorare la malattia residua, nota come malattia residua misurabile (MRD), con metodiche molecolari dotate di elevata sensibilità: lo scenario di profilassi quando la leucemia non è rilevabile tramite MRD; lo scenario di terapia ‘preemptive‘, quando la malattia è presente a livelli minimi, consentendo un intervento mirato prima che evolva in una ricaduta conclamata”.
Ma esistono ad oggi linee guida seguite nella pratica clinica? “Linee guida aggiornate non ve ne sono. Inoltre, la pratica clinica risulta esser particolarmente eterogenea e basata sulla politica dei diversi centri ematologici – sottolinea la ricercatrice. Ciò dipende soprattutto dalla mancanza di studi clinici prospettici e randomizzati con un elevato livello di evidenza scientifica.
L’unico studio randomizzato che ha rappresentato il caposaldo in tale contesto è datato 2013 e si riferisce al gruppo tedesco della Pfifer che ha dimostrato un vantaggio dell’utilizzo di TKI in profilassi rispetto al preemptive, sebbene non venga raggiunta la significatività statistica probabilmente legata all’esiguo numero di pazienti”.
L’unico documento che ha cercato di standardizzare l’approccio del mantenimento post-trapianto è un position paper dell’European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) risalente al 2016 che è stato un punto di riferimento per la pratica clinica. “Questo documento suggeriva il mantenimento post-trapianto a tutti i pazienti (sia in profilassi che preemptive) con il TKI imatinib o, in seconda battuta, dasatinib, per almeno un anno per i pazienti sottoposti a trapianto in prima remissione completa, o a tempo indefinito nei pazienti sottoposti a trapianto in seconda remissione completa”, spiega la dottoressa. Per quanto riguarda la realtà italiana, nel 2019 uno studio osservazionale del GITMO ha fornito una fotografia della pratica clinica condotta nei diversi centri. Lo studio si proponeva di riportare le caratteristiche del trapianto allogenico nella Ph+ ALL nei diversi centri italiani. Tra i risultati viene menzionato anche che in circa il 40% dei casi veniva eseguito un mantenimento post trapianto anche se con eterogeneità sia riguardo il tipo di TKI che la modalità di somministrazione se in profilassi o preemptive.
Negli ultimi anni, come accennato all’inizio, l’approccio terapeutico della leucemia linfoblastica acuta Ph+ è cambiato ulteriormente grazie alla combinazione di TKI e immunoterapia con blinatumomab, anticorpo monoclonale bispecifico, in grado di indirizzare la risposta dei linfociti T CD3+ verso la cellula leucemica CD19+.
“L’uso combinato di TKI e blinatumomab ha mostrato risultati sorprendenti con una tossicità assolutamente maneggevole: lo studio clinico GIMEMA LAL2116 D-ALBA con un follow-up di 53 mesi, ha infatti mostrato una sopravvivenza globale attorno all’80% e una sopravvivenza libera da malattia del 75.8%”, sottolinea la dottoressa.
“Il più recente protocollo GIMEMA ALL2820, studio clinico randomizzato di fase III che confronta un braccio sperimentale con blinatumomab e ponatinib versus imatinib e chemioterapia, sta mostrando dati ancora più promettenti con una sopravvivenza globale proiettata a 18 mesi del 91%, sebbene il follow-up mediano sia ancora breve. La profondità della risposta è significativa: il blinatumomab, aggiunto successivamente alla prima fase che prevede ponatinib e steroide, sembrerebbe incrementare la percentuale di negatività della MRD”.
Tra i TKI, il ponatinib sembrerebbe emergere come un possibile candidato ideale per il mantenimento post-trapianto. Rappresenta infatti il più potente tra i TKI ad oggi disponibili considerando il suo profilo farmacodinamico: risulta essere infatti un pan-TKI in grado di bloccare diversi meccanismi di attivazione della cascata tirosin-chinasica ed è l’unico in grado di superare la presenza della mutazione T315I di ABL, responsabile principale della resistenza ai TKI.
Riguardo alla durata ottimale del trattamento, mancano ancora dati definitivi; in tale contesto il recente studio americano condotto da Saini nel 2020 suggerisce che i pazienti sottoposti a trapianto allogenico in prima remissione completa debbano ricevere il mantenimento per almeno 24 mesi, con monitoraggio costante della MRD.
L’innovazione terapeutica ha portato a una selezione più mirata dei pazienti candidati al trapianto: come identificare quindi i pazienti che necessitano ancora del trapianto e di conseguenza del mantenimento post? “Ad oggi abbiamo dei validi e importanti strumenti che ci consentono di individuare i pazienti che beneficiano del trapianto allogenico”, spiega Canichella.
“Tra questi le caratteristiche biologiche della malattia all’esordio, la persistenza della MRD positiva in specifiche fasi della terapia e l’acquisizione di mutazioni di ABL che conferiscono resistenza”.
Guardando al futuro, Canichella illustra come migliorare la fase post-trapianto allogenico dei pazienti affetti da ALL Ph+: “Credo che innanzitutto siano necessari studi clinici randomizzati che possano evidenziare in modo schiacciante il vantaggio del mantenimento con TKI e che possano portarne all’approvazione in questa fase. Non bisogna infatti dimenticare che attualmente non vi sono in Italia TKI approvati per la fase post-trapianto allogenico. Lo sforzo da parte dei diversi gruppi di studio dovrebbe essere proprio questo. Da ultimo, non è da escludere che in un futuro prossimo anche altri farmaci possano essere impiegati nel mantenimento post-trapianto, come il blinatumomab stesso o l’inotuzumab, anticorpo monoclonale anti-CD22 coniugato con la calicheamicina. Ci sono infatti studi clinici in corso che stanno valutando l’approccio immunoterapeutico nella fase post-trapianto”, conclude la dottoressa.
L’articolo su Current Issues in Molecular Biology è disponibile qui: https://doi.org/10.3390/cimb47020129